venerdì 31 luglio 2015
Ancona: 29 settembre 1860
LA CONQUISTA DI ANCONA
CONCLUSIONE DELLA CAMPAGNA
NELLE MARCHE
29 SETTEMBRE 1860
Il 29 settembre 1860 è
l’ultimo giorno di Ancona sotto la dominazione del Potere temporale dei Papi,
iniziato con l’azione dell’Albornoz sei secoli prima. La resa della guarnigione
pontificia alle truppe sarde del generale Fanti, che la stringevano d’assedio
dal 23 settembre, fu pagata dalla dorica con danni noteVoli tra cui la
distruzione di un suo monumento: la Lanterna.
Ancona era assediata dal sud
dal V Corpo d’Armata al comando del generale Morozzo della Rocca, da nord, da
quelle del IV Corpo al comando del generale Cialdini. Questi era reduce dalla
battaglia di Castelfidardo, combattuta il 18 settembre sulle pendici di Colle
Oro,davanti a Loreto, che da un punto
puramente tattico, si può definire la prima battaglia per la conquista di
Ancona, nel quadro della campagna nelle Marche da parte dell’Esercito Sardo. Un
notevole contributo a questa giornata vittoriosa fu dato dalla flotta al comando
dell’ammiraglio Persano. Infatti la squadra sarda si era presentata davanti
alle acque di Ancona il 17 settembre e si era ancorata, la sera, davanti a
Senigallia. Qui il Persano scese a terra e raggiunse il Cialdini al auo
quartier generale a Sant’Agostino, sotto Castelfidardo, e concertò con lui il
piano per il giorno successivo.
Compito suo era quello di
trattenere la guarnigione pontificia di Ancona, al comando del De Courthen che
proprio quel 17 settembre di buon mattino era uscita con una colonna di 4000
uomini per incontrare le forze
pontificie, circa 8500 uomini, provenienti dall’Umbria al comando del De
La Moricère. Cialdini voleva evitare che
il 18 settembre le forze pontificie avessero la possibilità di riunirsi .
Persano doveva presentarsi davanti il porto di Ancona e bombardare i forti e
minacciare sbarchi, costringendo così De Courthen a non tentare sortite.
Permettendo a Cialdini di contenere prima e poi a disperdere le
forze di De La Moriciere, Persano bombardò tutta la giornata Ancona, bloccando
la guarnigione anche con la minaccia di sbarchi, e molti colpi raggiunsero case della dorica,
provocando molti danni. Uno di questi è particolarmente interessante da
raccontare.
Gli Amici dell’ Albergo “
Roma”, un programma non confermato
I Sardi avevano organizzato un
servizio di informazioni, riuniti in un Comitato, all’interno della dorica, che
tenne correntemente informato il Comando Sardo dall’andamento delle operazioni
pontificie. Alcuni componenti di questo Comitato lavoravano all’ Albergo
“Roma”, quello che oggi è l’Albergo Roma e Pace , in via Leopardi, e
convinsero il proprietario, vedendo le manovre della Flotta e la chiara
intenzione di minacciare sbarchi a preparare per la sera del 18 un ricco menu:
i comandanti Sardi sarebbero stati ben accolti da Ancona liberale.
I cuochi e tutto il personale
fu eccitato da questa inIziativa e tutto l’albergo partecipava ai preparativi.
Purtroppo l’uomo propone e dio dispone; nella fattispece le disposizioni
degli dei furono tutte in uno dei ultimi colpi nelle prime ore del pomeriggio
sparati dalle navi sarde: questo proietto concluse la sua parabola sul tetto
dell’Albergo “Roma” che penetrò all’interno ed arrivò, di piano in piano, fino
alle cucine; non fece vittime, ma procurò danni molti calcinacci e molta
polvere, che come si può comprendere cadde sui preparativi e sui cibi per la
grande cena della liberazione.Oltre al danno
per i nostri patrioti non poteva non esserci che la beffa.
Il De La Moricière, sconfitto
a Colle Oro, verso del due del pomeriggio del 18 settembre raggiunse Umana e
per un soffio non fu fatto prigioniero, raggiunse il convento dei Camaldolesi
sulla cima di Monte Conero, scese poi al Poggio
e raggiunse, attraverso la valle degli Orti, quello che oggi è il
quartiere Adriatico, Porta Calamo ( Piazza Roma) e fu accolto dalle autorità
pontificie di Ancona sulla piazza davanti alle Muse. Qui comunicò le tristi
notizie della giornata ( erano le 17,30 del 18 settembre) e un’ora dopo fu
accompagnato all’albergo “Roma”, per riprendersi dalle fatiche e strada facendo
fu informato, perché ieri come oggi, ad Ancona si sa tutto, dei progetti del
patrioti dell’Albergo “Roma”.
Messo di buon umore, ben
accetto di mettersi a tavola e, insieme ai suoi comandanti, De La Moricière
consumò la cena, tra risate e un po’ di scherno, non preparata per lui, sotto
gli occhi di chi avrebbe preferito vedere altri generali al suo posto.
Una flotta all’attacco
Ma la cena con i desiderati
protagonisti era solo rinviata. Dopo Castelfidardo tutte le forze sarde ebbero
l’ordine da Fanti di confluire su Ancona. IL 23 settembre, proprio Persano
dichiaro il blocco dal mare della città. Questa,intanto, si preparava
all’assedio. Vi erano due linee di difesa: una esterna, che si appoggiava ai
forti Scrima, di Monte Pulito, Monte Pelago e Pietralacroce; una interna che
andava dal Cardeto, ai Capuccini, lungo le mura ove si aprivano le porte Farina
e Calamo, in fondo come detto alla valle degli Orti, l’Astagno con la
Cittadella, che dava sostegno al cosidetto campo trincerato, che includeva la
Lunetta Santo Stefano con la relativa porta (qui arrivava la strada postale per
Roma), e verso nord la Porta di Capodimonte terminando a Porta Pia, cerniera tra terra e mare con il
Lazzaretto.
Lungo il Porto vi erano i bastioni
di Santa Lucia e d’Agostino fino al molo nord in cui si eregeva La Lanterna. Il
De La Moriciere in queste mura, ad Aprile del 1860 quando ispezionò Ancona per
la prima volta fece aprire un varco quello che oggi è tra la Banca d’Italia e
il Palazzo della RAI, a piazza delle Muse, per dare più respiro al Porto. I
vecchi anconetani lo chiamavano il
“delamoriciere”. Il porto era chiuso da una catena collegata dal molo, a sud, e
a nord alla base della Lanterna.
Purtoppo la difesa non aveva
abbastanza forze per occupare tutte queste posizioni. Sarebbero occorse oltre
8/9000 uomini; ve ne erano solo 4000 disponibile. Quindi ai primi attacchi la
difesa esterna doveva essere abbandonata e tutti i difensori dovevano
raggiungere le posizioni della difesa interna. Il 26 settembre, quando le
truppe di Morozzo della Rocca raggiunsero Pietralacroce, il forte era
presidiato da due compagnie pontificie. Senza che ci fosse ordini precisi i
fanti del 40° Reggimento iniziarono un cenno di attacco; questo ebbe successo e,
coinvolte altre truppe conquistarono il forte, poi arrivarono nell’abitato e
proseguirono verso il forte di Monte Pelago e Monte Pulito investendolo. Qui
furono fermati. A ricordo di questi combattimento è stato eretto un Monumento,
oggi circondato dagli alberi, da una catena, e
nascosto alla vista di tutti.
Cavour, anche ministro della Marina, voleva per la Marina Sarda un momento di
gloria, e incitava il Persano ad azioni ardite. L’Ammiraglio tentò di prendere
Ancona con dei colpi di mano; messe in mare la sera del 25, e poi la sera del
26, delle lance, e l’ultima spedizione la guidò personalmente, tentò di
conquistare le posizioni del Lazzaretto. I colpi di mano non riuscirono, ma
indebolì le difese del Lazzaretto e il giorno successivo, 27 settembre, i
Bersaglieri del IV Corpo, ebbero modo di assaltare la Mole Vanvitelliana e
conquistarla.
Questo privò la difesa del porto del suo pilastro
sud, cosa che sarà determinante il giorno successivo. La mattina del 28 Persano
ebbe l’ordine da Fanti di una azione generale della flotta per saggiare le
difese della piazzaforte e mettere a punto l’attacco di terra, essendo ormai
tutte le truppe giunte a ridosso di Ancona.
Persano ordinò alle sue navi, (la squadra era
composta dalla Maria Adelaide, dal Governolo, dal San Michele,
il Cavour, dal Costituzione, dal Vittorio Emanuele II ed
altre minori a sostegno.
Le navi manovrarono
per iniziare il tiro contro le difese. La Maria Adelaide era in riserva, tutte
le altre iniziarono in breve un tiro preciso e mirato. Il mare non era
calmo, e soffiava un vento teso di
scirocco. Il tiro controcosta da parte di navi era eseguito ancorando le navi
il più possibile, per dare agli artiglieri
la massima stabilità, da cui dipendeva la precisione del tiro
stesso. Il Vittorio Emanuele II,
al comando del capitano Albini, vice di Persano, dopo un ora di fuoco, per via
del vento che andava rinforzandosi e del fatto che si era ancorato non
sufficentemente, veniva dal vento portato fuori dalla linea di tiro.
Il gen Fanti e gli altri comandanti Sardi stavano
vedendo l’azione della Marina da Posatora, con i binocoli; Fanti vedendo il
tiro efficace della flotta, fece trasmettere alla Maria Adelaide i
propri complimenti. Persano, sulla Maria Adelaide li ristramise alle
navi in linea di tiro. I saluti non giunsero al Vittorio Emaniele II che
nel frattempo era stato portato al largo, arando il fondo. L’Albini, piccato da
tutto questo, e irritato che la sua nave non riusciva a mantenere la posizione,
chiese libertà di manovra, che gli fu accordata.
La manovra del Vittorio Emanuele II, è
all’origine della caduta di Ancona. Ripresa la linea di navigazione con un
ampio cerchio con andamento nord-est si mise in modo tale da puntare diritto
sulla Lanterna. Alla debita distanza virò verso destra, puntando a nord ovest,
e mise tutti i suoi cinquanta cannoni della fiancata di sinistra pronti al
tiro. Il Vittorio Emanuele II passo a soli cinquanta metri dalla
Lanterna; gli artiglieri sulla nave spararono ad alzo zero, in sequenza.
L’effetto fu devastante. I colpi finirono di distruggere la batteria “in
barbetta”, già colpita, della Lanterna; uno degli ultimi ( le fonti pontificie
dicono che rimbalzò varie volte all’interno della casamatta alla base della
Lanterna stessa) entrò nella Santa Barbara, che poco dopo esplose. In quel
momento uno dei monumenti di Ancona andava in frantumi, seppellendo oltre 125
artiglieri pontifici. Il tremendo boato scosse tutta la città e la nuvola di polvere avvolse ogni cosa; crollava
il sostegno della catena, che affondava. Il porto era aperto e libero per le
compagnie di sbarco. L’azione dell’Albini ebbe vasta eco nelle marinerie del
tempo, in cui si iniziò a pensare che era possibile il tiro contro costa in
movimento. Perfino la Royal Nevy mandò ad Ancona, nei mesi successivi, una
commissione a studiare come erano andate le cose.
Erano le 16 pomeridiane del 28 settembre 1860. Dopo
mezz’ora da tutti i forti di Ancona si alzò la bandiera bianca.
Una nota triste. Comandava la batteria della
Lanterna il ten. Wiesenthal. Questi era di ricca famiglia austriaca, ed amava
il mestiere delle armi. Un bel giovane, fine, di buone maniere, che la
primavera prima aveva conosciuto una ragazza altrettanto bella e di buona
famiglia; si innamorarono e progettavano di sposarsi alla fine dell’estate. Poi
lui era dovuto partire e la destinazione fu Ancona. Avevano deciso, prima che
la guerra scoppiasse, di sposarsi proprio nella Dorica e viverci, data la
bellezza della città, a fine settembre. Lei sarebbe giunta appena possibile ad
Ancona per sposarsi e Wiesenthal non faceva che chiedere notizie per sapere se
la guerra poteva incidere sui suoi progetti.
Faceva vedere
la foto a tutti, ed era veramente innamorato. Wiesenthal rimase sotto le
macerie della Lanterna. Lei raggiunse Ancona appena libera. Il Quattrebarbes,
governatore di Ancona pontifica, che ci racconta questa vicenda, nel suo
“Souvenirs d’Ancone” non ci dice quello che accade nei particolari, ma dice che
fu “tutto molto triste”. Altre fonti dicono che Lei riportò in Austria il suo Wiesenthal
ed Ancona gli rimase sempre nel cuore.
Ma di vicende, non solo tristi, che qui non vi è
spazio per narrarle è ricco questo
Assedio di Ancona, il terzo, in cinquant’anni, dopo quello del 1799, e del
1849, Un assedio di cui pontifici e Sardi protagonisti di quegli eventi
serbarono sempre in gran bel ricordo di Ancona.
De La Moricière mandò i parlamentari di resa a bordo
della Maria Adelaide; Persano li rimandò indietro comunicando che solo
il gen. Fanti poteva accettare la resa. In questo andirivieni di parlamentari,
nonostante che le bandiere bianche fossero esposte, il Fanti alle 22,30 di sera
ordinò di riprendere il fuoco con le batterie di campagna. Questo mancanza di
rispetto della bandiera bianca fu oggetto in seguito di violente polemiche soprattutto
in Francia. La mattina del 29 settembre l’attacco generale era pronto, ma
finalmente i parlamentari giunsero davanti alla persona giusta. La resa fu
firmata a Villa Favorita, sotto Castro, sede del Comando di Fanti.
Ancorchè caduta il 28 settembre, la resa fu firmata
ufficialmente il 29 settembre. Finalmente i nostri amici dell’albergo “Roma”
potevano festeggiare come si deve. Ancona era italiana, e come è di regola,
pagò la sua libertà ad un prezzo non certo basso. Della Lanterna è rimasto solo
il basamento dove fu successivamente costruita l’infermeria della Marina
Militare. La via che ancora oggi ricorda quegli eventi, Via 29 settembre
1860, corre lungo la difesa a mare tra
Porta Pia e il bastione di Santa Lucia fino al “delamoriciere”.
Ed è un piacere passeggiarci, guardando il porto, la
base della Lanterna, porta Pia, spesso pensando anche alla vicenda del tenente Wiesenthal ed alle altre
vicende di quei giorni che ti rendono non certo indifferente ed apparire insignificante quel “29 settembre 1860”.M.C.)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

















































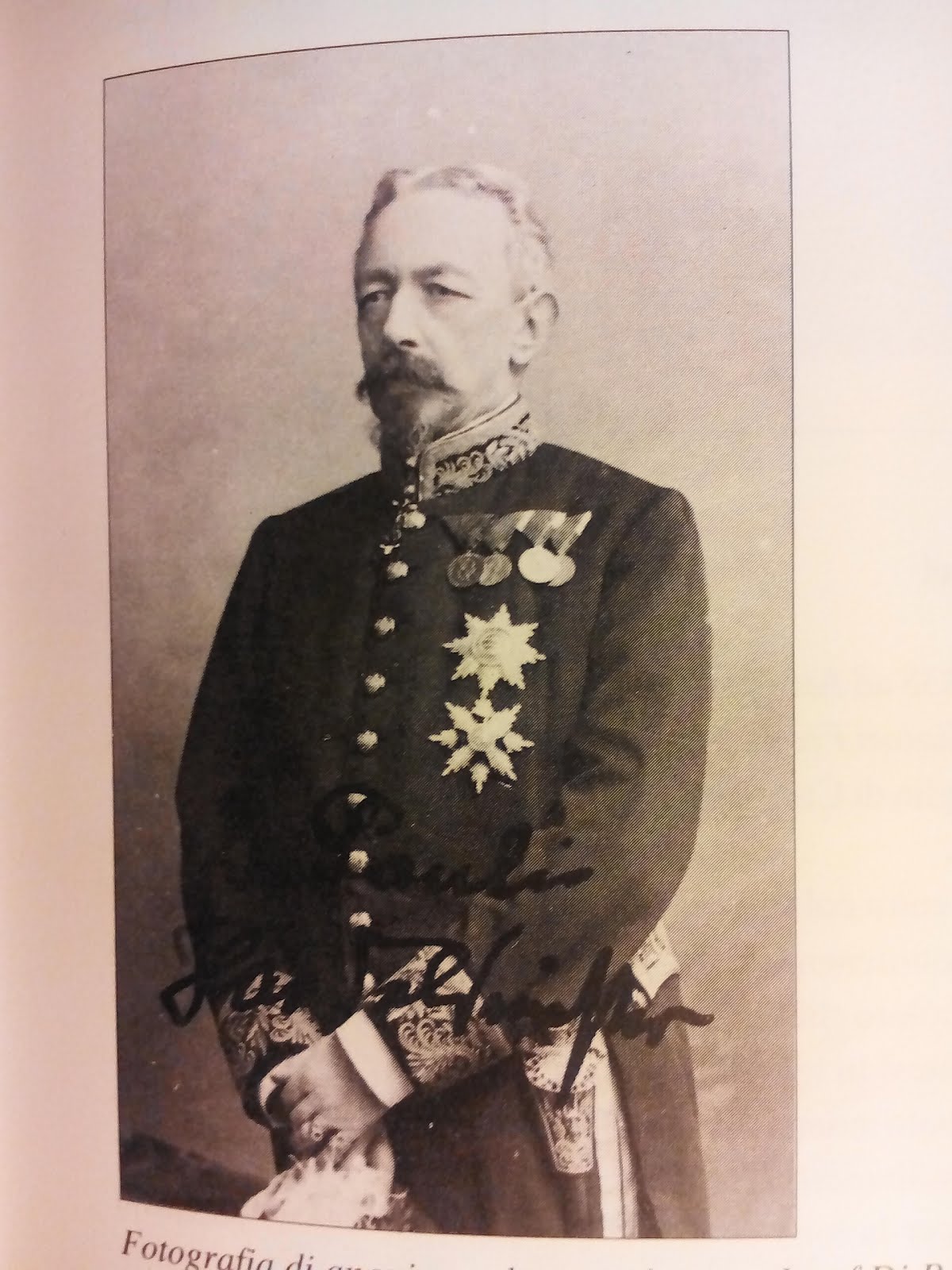






















































































Nessun commento:
Posta un commento