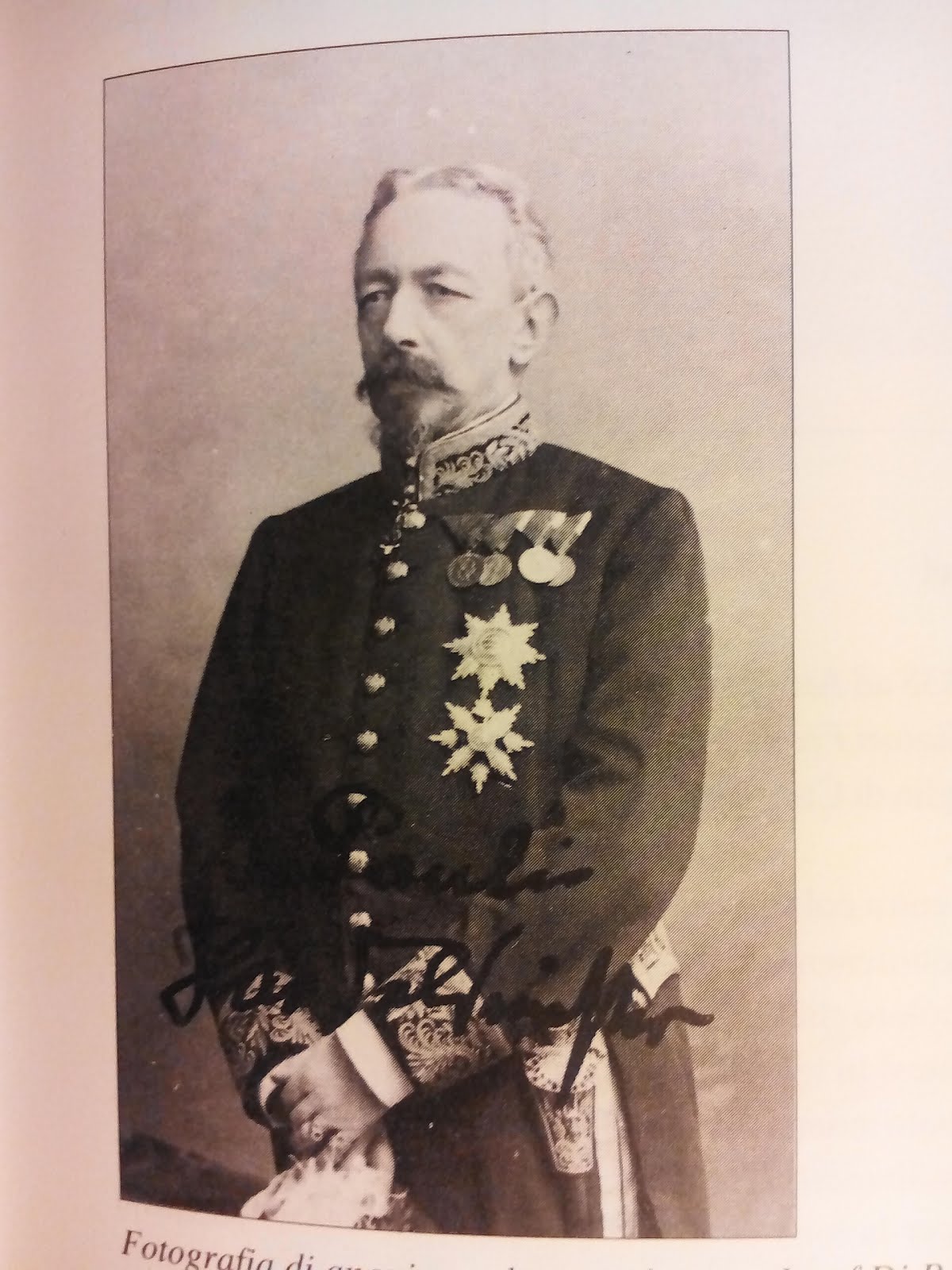venerdì 27 novembre 2015
lunedì 16 novembre 2015
venerdì 6 novembre 2015
domenica 1 novembre 2015
giovedì 29 ottobre 2015
giovedì 15 ottobre 2015
domenica 4 ottobre 2015
Galleria del Figurino Storico. Osimo. Plastico. 18 settembre 1860 ore 06.00
SCONTRO DI LORETO
18 SETTEMBRE 1860
IL PLASTICO
RIPRODUCE LA SITUAZIONE ALLE ORE 06.00 DEL 18 SETTEMBRE 1860
QUANDO L'ESERCITO PONTIFICIO SI RADUNA
NELLA PIAZZA ANTISTANTE LA BASILICA DI LORETO
PER SCENDERE
NELLA SOTTOSTANTE PIANA DEL MUSONE
E PUNTARE SU ANCONA
 |
| La Basilica di Loreto |
 |
| La piazza antistante la facciata della basilica di Loreto |
 |
| Lato est della Piazza. Sul sagrato della Basilica il Vescovo di Loreto ed il Comandante delle truppe pontificie gen De La Moriciere |
 |
| L'artiglieria a cavallo e la cavalleria pontificia |
 |
| La fanteria pontificia |
 |
| In primo piano i tiragliatori franco-belgi che nel 1861 diventeranno Zuavi Pontifici |
LA DESCRIZIONE DELLA GIORNATA 18 SETTEMBRE 1860 E' NEL VOLUME
IL COMBATTIMENTO DI LORETO,
DETTO DI CASTELFIDARDO,
Roma, Edizioni Nuova Cultura - Università La Sapienza, 2009
info:
www.storiainlaboratorio.blogspot.com
venerdì 25 settembre 2015
martedì 15 settembre 2015
Tambini Luigi, sottufficiale di artiglieria
 |
| Luigi Tambini |
Non sono conosciuti il luogo
e la data di nascita e di morte. Sottufficiale dell’artiglieria pontificia nel
1866 partecipò alla battaglia di Mentana.
Intimo dei conti Bernardii di
Lucca, provvide a recuperare il corpo del conte Carlo, maresciallo di
Artiglieria caduto in quel fatto d’armi, sepolto dapprima a Monterotondo, per
consegnarlo al fratello conte Martino ( Lucca 1844-1935) maresciallo dei
Dragoni, poi sottotenente nello stesso corpo. Lasciata la carriera militare
divenne sacerdote. Era decorato della medaglia Fidei et Virtuti.
Fotografia Sidoli. Fotografo Primato Roma Piazza di
Spagna n. 32 Piacenza via Dritta n. 6 (cm 10,6 x6,3)
Al verso la dedica: Al Sig. Balduino Marocchi in segno di amicizia. L. Tambini Roma li 8 novembre 1866
Fonte: Raggi P., La Nona
Crociata. I Volontari di Pio IX in difesa di Roma (1860-1870), Ravenna,
Libreria Tonini, 1992
giovedì 10 settembre 2015
sabato 5 settembre 2015
Orazione Funebre per Giambattista Malin
CESARE MALIN
ORAZIONE FUNEBRE IN MORTE DI
GIAMBATTISTA MALIN
Ecco il testo in caratteri a stampa:
“Dalla culla alla tomba è un breve passo!”
Così il Monti
Signori,
Malin Giambattista che fino a pochi giorni or sono, impavido sfidava gli sguardi della
morte, ora è freddo cadavere!....
Per lui si compirono i tre grandi avvenimenti della vita, ed ora tra il lugubre silenzio di
questo recinto, si svolge il periodo di sua trasformazione; per lui è già sorta l'alba della vera
eguaglianza e giustizia!...
Noi che abbiamo avuto campo di avvicinarlo e d'indovinarne le nobilissime aspirazioni e che
ora ci troviamo mestamente radunati intorno alla sua bara, abbiamo ben donde d'essere in preda a
quel cupo dolore, che solo il tempo potrà guarire, né troviamo parole adeguate per esprimerlo:
Curae leves loquuntur, ingentes stupent!...
Sebbene la sua posizione gli assicurasse gli agi della vita, pure nella breve sua esistenza, si
trovava attorniato da continue sofferenze che in sul mezzogiorno della vita, lo trascinarono alla
tomba!...
Fu tra i coraggiosi volontari Villanovesi che nel 1859, nella pienezza del loro bollore
giovanile, entusiasti alla vista della coccarda tricolore, accorsero alla campagna Lombarda a difesa
della Patria, varcando il Po presso Ferrara, che le pattuglie austriache continuamente guardavano.
Spossato e stanco combatté e vinse contro l'inespugnabile fortezza d'Ancona, dove entrava
trionfante alle ore 2 pomeridiane del 29 Settembre 1860, colla sua compagnia ch'ebbe l'alto onore
d'esserne eletta all'assalto sotto il comando del Generale Cialdini.
Nel governo del Comune mostrossi sempre zelante e rigoroso nella più esatta osservanza
delle Leggi e dei Regolamenti, ed anelava più che mai all'imparziale difesa degli interessi e della
pace de' suoi amministrati.
Era fornito di egregie doti e non comuni di mente e di cuore; ebbe savi principi, fu con tutti
affabile, tenero amico e disinteressato, e mostrò dovunque la propria abnegazione.
Nei pochi anni ch'ebbi la bella sorte di averlo a Capo del Comune, mi colmò di affettuose
premure, s'adoprò in ogni maniera per rendere inconcussa la meschina mia posizione mi amava
propriamente....... di che non potrò che serbargli grato e incancellabile ricordo!.....
Pieno di tutta pazienza, meco divideva i dispiaceri che purtroppo s'incontrano
nell'esecuzione del difficile mandato di Pii Amministratori.
Non appena il buon Giambattista stava per toccare il nono lustro di sua età, fu assalito da
terribile e penosissima malattia che lo ridusse pressoché uno scheletro informe!....
L'amorevole famiglia fino alle ultime ore di sua vita, lo vide rassegnato a salutare per
sempre questa valle di lacrime e di dolore, e dopo ricevuti i conforti della Religione, in sul mattino
di jer l'altro, l'inevitabile falce della morte lo strappava all'affetto nostro, rimanendo così spento un
altro rampollo della sua sgraziata famiglia che troppo di frequente la vediamo spiegare le nere
gramaglie!...
Dinanzi a tanta straziante sventura lice a noi soltanto, vil pugno di creta, di piegare la fronte
al Supremo volere di chi regge i destini delle umane cose, né possiamo indovinare quali possano
essere gli arcani intendimenti della Divinità, quando in sì aspra e terribile guisa fa gravare la sua
mano sopra l'uomo!...
La morte del caro e amato Giambattista, ha destato nel paese il pianto e la costernazione, e la
sua vita intemerata sarà per noi giovani di grande esempio e di durevole memoria!...
A quest'ora l'anima sua benedetta ai sarà avvinta al braccio di Dio e possa così eternamente
godere di Celesti Carismi accanto alla sua cara sposa, e noi in oggi cogli occhi irrorati dal pianto
l'ultimo vale gli diamo!!!!!........
Villanova del Ghebbo li 29 Febbrajo 1881
Cesare Malin Impiegato com.le e Membro della Congregazione di Carità
L'originale dell'orazione è di proprietà di Renzo Carlo Avanzo.
Nota di Renzo Carlo Avanzo, nipote di Cesare Malin, suo nonno materno.
Giambattista Malin è così citato nel volume
“Polesine in armi -I protagonisti delle battaglie
risorgimentali 1848-1870”” di Luigi Contegiacomo e Laura Fasolin edito dal Ministero per i Beni e
le Attività Cultura Culturali – Archivio di Stato di Rovigo – Associazione Culturale Minelliana –
Rovigo 2011:
MALIN GIOVANNI BATTISTA
di Vincenzo e Teresa Vigna, di Lendinara n. 1837 ca,., m. 27,02.1881, possidente, sposato con
Filomena Bassani.
Campagne militari: 1866.
Durante l'interrogatorio del 16 maggio 1861, il Malin dichiara di essersi allontanato dalla sua città
nell'ottobre del 1859 per raggiungere Ferrara, di non aver servito in corpi militari ma di essere
spinto a tale decisione da “circostanze di famiglia”. Seguirà ulteriore interrogatorio nel mese di
giugno.
Dall'orazione dì Cesare Malin si desume invece che Giambattista probabilmente si arruola nelle
truppe del Regno di Sardegna forse come ufficiale, visto che si parla di una “sua compagnia”
quando entra ad Ancona alla fine dell'assedio o forse partecipa semplicemente a qualche formazione
di volontari. Questa seconda possibilità è più coerente col fatto che non si trovano sue tracce né
all'archivio di stato di Torino né a Roma all'archivio dell'esercito.
Premesso che Giambattista Malin era di Valdentro, frazione allora, durante il dominio austriaco, di
Fratta Polesine e non di Lendinara, ma in realtà facente parte della comunità religiosa e civile di
Villanova del Ghebbo di cui, come si evince dalla lettura dell'orazione, è addirittura sindaco, dalle
ricerche da me fatte nell'archivio parrocchiale di Villanova del Ghebbo risulta che egli è padrino di
Adolfo Rossi, anche lui di Valdentro, che diventerà una importante personalità del giornalismo e
della diplomazia a cavallo tra XIX ed XX secolo, ma è anche zio dello stesso in quanto fratello
della madre di Adolfo, Filomena Malin. Giambattista, quando muore, era già vedovo della moglie
morta in giovane età, di qui il riferimento dell'oratore alla “sgraziata famiglia”.
Cesare Malin si dichiara, in alcune sue lettere, cugino di Adolfo Rossi evidentemente per via della
madre che è una Malin Non è però ancora chiaro il legame tra i fratelli Giambattista e Filomena e
Cesare Malin. E' probabile che essi abbiano i nonni paterni in comune e che anche per questo
legame Cesare Malin sia stato chiamato a intonare l'orazione funebre per Giambattista.
L'intensa citazione latina “Curae leves loquuntur, ingentes stupent” che si può tradurre con “Le
preoccupazioni lievi parlano, ma quelle grandi tacciono” è tratta dalla tragedia “Phedra” di Seneca.
E' da notare infine che, al momento della lettura dell'orazione, Cesare Malin aveva solo 28 anni.
lunedì 31 agosto 2015
Theodoli marchese Giuliano. Biografia
Di antica famiglia nasce a
Roma il 27 dicembre 1846.
Nel 1867, tralasciati gli
studi letterari, si arruola nella artiglieria pontificia: soldato distinto l’8
giugno 1867 partecipa valorosamente alla campagna di quell’anno, culminate con
la vittoria di Mentana. E’ promosso brigatiere il 26 aprile 1868 maresciallo
l’11 novembre 1869, sottotenente il 5 febbraio 1870. E’ presente alla difesa di
Roma dove rimane contuso e semisepolto dai detriti provocati dallo scoppio di
un proiettile piemontese. Condotto con altri suoi compagni in prigionia ad
Alessandria rifiuta ogni lusinga di arruolamento nell’esercito vincitore,
raggiungendo poi il grado pontificio di
colonnello onorario di Artiglieria. Muore a Roma il 28 maggio 1926. Era
decorato della Medaglia Fidei et Virtuti
Fonte: Raggi P., La Nona
Crociata. I Volontari di Pio IX in difesa di Roma (1860-1870), Ravenna,
Libreria Tonini, 1992
venerdì 21 agosto 2015
Raggi P., La Nona Crociata. I Volontari di Pio IX in difesa di Roma (1860-1870), Ravenna, Libreria Tonini, 1992
La storia ha reso giustizia a
quanti difesero, anche a presso della loro vita, La Chiesa ed il Papa nel lungo decennio che va dallo scontro di
Castelfidardo e dalla perdita di Ancona alla breccia di Porta Pia, ma rimangono
tuttavia echi di antiche polemiche alimentate dalla scarsa informazione sulla
realtà dei fatti.
Una “certa “storia scritta
dai “vincitori” non manca infatti di ingenerose affermazioni e di immotivati
giudizi, spesso ripetuti negli stessi termini di un tempo. Era quindi
necessaria una notizia ampia e documentata su episodi e motivazioni egli ultimi
crociati unicamente mossi dalla loro fede e dai loro ideali. La introduzione
storica di questa opera, le biografie dei protagonisti e la Galleria di
immagini e documenti dell’esercito pontificio definiscono le dimensioni ed i
termini della questione.
Le ottanta e più biografie di personaggi e militari
evidenziano il valore degli uomini ed il significato della loro opera nel
contesto più ampio che comprende atti di valore al servizio della propria
patria o missioni di carità e di giustizia nella vita civile. Di ognuno vengono
date notizie essenziali e spesso anche immagini fotografiche reperite
dall’Autore in lunghi anni di ricerca in Italia ed all’estero, acquisendo una
originale documentazione alla propria raccolta di carte e cimeli. Si tratta
spesso di materiale inedito e sconosciuto che, con la vasta bibliografia,
arricchisce l’opera e la rende uno strumento di conoscenza e di consultazione
perfetta.
Chi avesse notizie
integrative su questo volume o su altri similari è pregato di prendere contatto con il
sottoscritto.
Massimo Coltrinari.
Contatti:
massimo.coltrinari@libero.it
mercoledì 19 agosto 2015
de Stolberg, conte
Appartenente certamente alla
famiglia dei conti di Stolberg regnate in Germania fino alla caduta del Sacro
Romano Impero (1806) precisamente al ramo di Fedrico Leopoldo (7 novembre 1750
5 dicembre 1819) uomo politico e poeta fattosi cattolico nel 1800 con la
famiglia. La discendenza può essere ricostruita attraverso i figli Caio, Leopoldo e Bernardo (che fu novizio
gesuita) e Giuseppe ma non definita ulteriormente nei numerosi nipoti. Ricoprì
il grado di sottufficiale degli Zuavi.
In calce la firma Stolberg
Fonte: Raggi P., La Nona Crociata. I Volontari di Pio
IX in difesa di Roma (1860-1870), Ravenna, Libreria Tonini, 1992
Chi avesse notizie
integrative per questa biografia è pregato di prendere contatto con il
sottoscritto.
Massimo Coltrinari.
Contatti:
massimo.coltrinari@libero.it
martedì 18 agosto 2015
Wyart Henri
Nasce ad Bauchian, nel nord
della Francia il 13 ottobre 1839. Si arruola nel battaglione Tiragliatori Franco-
Belgi il 22 agosto 1860, partecipa alla
battaglia di Castelfidardo dove viene ferito da una palla che gli spezza
l’avambraccio sinistro e da un colpo di
baionetta al collo. Passa al corpo degli Zuavi il 13 febbraio 1861. E’ nominato
sergente il 21 marzo 1861 sergente maggiore il 6 marzo 1866 sottotenente il 17
marzo 1866 , tenente il dicembre successivo. Si distingue per il suo
comportamento a Mentana e viene promosso capitano il 23 novembre 1927. E’
presente alla difesa di Roma quale capitano aiutante maggiore dello Stato
Maggiore del suo reggimento. Il 15 ottobre 1870 si reca in Francia dove, col
grado di capitano della Legione Volontari dell’Ovest combatte contro i
prussiani nei fatti d’arme d’Orleans, di Brou e di Loigny ricevendo la
promozione a capitano aiutate maggiore. Il 5 febbraio 1872 entra nell’Ordine
dei Cistercensi Roformati. Il 30 gennaio 1883 è abate della Trappa du Mont-des-
Cats col none di Don Sebastian. L’ 11
ottobre 1892 è nominato abate generale del suo ordine. Muore a Roma il 18
agosto 1904 d è sepolto a San Paolo alle
Tre Fontane . Era insignito della Legione d’Onore , della croce dell’Ordine
Piano, della croce di cavaliere dell’ordine di San Gregorio Magno e decorato
delle Medaglie Pro Preti Sede, Fidei et Virttuti, Benemerenti
Foto: Fotografia di Anonimo
Fonte: Raggi P., La Nona Crociata. I Volontari di Pio
IX in difesa di Roma (1860-1870), Ravenna, Libreria Tonini, 1992
Chi avesse notizie
integrative per questa biografia è pregato di prendere contatto con il
sottoscritto.
Massimo Coltrinari.
Contatti:
massimo.coltrinari@libero.it
domenica 16 agosto 2015
Esercito Pontificio 1860 1870
Il Corpo di Amministrazione
Ordinamento
Il Corpo degli Ufficiali di
Amministrazione , alle dipendenze della Intendenza Militare, viene costituito
il 23 dicembre 1858 per fornire esperti contabili dell’Esercito, comprendeva
dopo l’ampliamento di organici effettuato nel 1869, 34 ufficiali ed allievi,
equiparati quest’ultimi ad aiutanti
sottufficiali.
Uniforme
L’Ordine del Giorno 13 luglio
1860 relativo all’uniforme del Corpo prevedeva:
-
Abito per la gran
tenuta
L’abito
a falde era quello consueto con una fila di nove bottoni dorati con il triregno
in rilievo, colletto pure blu scuro con filettature di robbio, paramani rotondi
con due bottoncini a tasche alla “Saubise” pure filettate in robbio.
-
Tunica per la
tenuta giornaliera
Di
colore blu scuro con filettature coloro robbio
-
Pantaloni color
robbio simili a quelli in uso alla Fanteria
-
Feluca con
coccarda a ganza d’oro e fiocchetti negli angoli pure in oro a granoncini per gli Ufficiali
-
Feluca con
coccarda a ganza d’oro e fiocchetti negli angoli a filo per gli Allievi
-
Berretto blu
scuro con distintivi in oro, simile a quello della Fanteria
-
Distintivi
I distintivi
di grado, in oro, consistevano in una bacchetta dentellata ed in una o più
bacchettine diritte arricchite di lustrini:
.
per gli Ufficiali di Amministrazione la
bacchetta dentellata e tre bacchettine
diritte
al colletto dell’abito e della tunica e la bacchetta dentellata ai paramani
dell’abito;
. per
gli Aiutanti di Amministrazione di II e di I Classe la bacchetta dentellata
portata
al colletto dell’abito e della tunica con una o due bacchette diritte
.
per gli Allievi di Amministrazione la sola bacchetta dentellata portata al
colletto
dell’abito o della tunica.
Equipaggiamento
Per il corpo d
Amministrazione, si presume, non esistessero materiali di equipaggiamento per
operazioni di campagna.
Armamento
Il Corpo di Amministrazione
non aveva dotazioni di armamento di reparto. Ogni suo componente aveva in
dotazione una spada a cinturone simile a quelle in uso per l’Intendenza
Fonte: Crociani P., Brandani
M., Fiorentino M., L’Esercito Pontificio
da Castelfidardo a Porta Pia 1860-1870 Uniformi Equipaggiamento Armamento, Milano, Intergest, 1984
sabato 15 agosto 2015
Guerin Ioseph Louis
Nato a Sainte Pazanne, Loira
Inferiore, il 5 aprile1938 era chierico minore dei seminaristi di Nates quando,
nell’agosto del 1860 accorse all’appello di Pio IX. Lasciato l’abito
ecclesiastico si arruola nel corpo dei Tiragliatori Franco belgi. Dopo un breve
addestramento a Roma al precipitare degli eventi per l’invasione piemontese
delle marche e dell’Umbria, lascia Roma col suo battaglione per Terni, Spoleto,
Foligno, Loreto giunge a Castelfidardo il 17 settembre 1860.
Partecipa tra i più animosi
alla battaglia di Castelfidardo, dove viene gravemente ferito in località
Crocette da una palla ricevuta nel lato sinistro del petto. Creduto morto, così
iegli in una lettera ai parenti, viene spogliato di ogni suoi avere, poi
raccolto da una ambulanza e trasportato alla basilica di Loreto che funge da
centro raccolta dei feriti; fra queti troverà l’amico caporale Guillemin (Il
tenente Guillemin, scampato miracolosamente alla morte, perirà il 13 ottobre
1867 all’attacco di Montelibretti). In seguito Guérin è trasferito all’ospedale
di Osimo dove muore il 30 ottobre successivo per cancrena, nonostante le
assidue cure dei medici italiani e francesi.
Dall’ospedale scrive ai
genitori, ai parenti, ai superiori del Seminario numerose lettere di nobile
rassegnazione, di conforto per quelli che lascerà, di perdono per i nemici, di
fede nella grande causa per la quale immola volentieri la vita; possiamo
considerare una di queste indirizzata al proprio parroco, come un vero
testamento spirituale
“…. Me perire pro. causa Religionis et Papae et vitam amoene et
dulciter reliquisse. Consoletur parentes meos spe olim me vivendi in patria,
terra est sorditissima, quando coelo comparatur. Oret pro me, et sic animo
leventur. Eos multum multunque anno , et eos relinquo cum solo dolore non posse
amplexart eas…”
La salma verrà imbalsamata e
trasportata a nantes per essere collocata nel cimitero del Seminario; la tomba
divenne presto meta di assiduo pellegrinaggio e di miracolose guarigioni
ottenute per intercessione
Foto: da una litografia H.1 Martin edit Paris
(cm 17x12)
Fonte: Raggi P., La Nona Crociata. I Volontari di Pio
IX in difesa di Roma (1860-1870), Ravenna, Libreria Tonini, 1992
Chi avesse notizie
integrative per questa biografia è pregato di prendere contatto con il
sottoscritto.
Massimo Coltrinari.
Contatti:
massimo.coltrinari@libero.it
giovedì 13 agosto 2015
Gallo conte Giuseppe Enrico
 |
| Conte Giuseppe Enrico Gallo |
Nato ad Osimo (Ancona) da
famiglia di fedeli sudditi pontifici il 1° 1849 Giovanissimo risponde
all’appello del suo sovrano accorrendo a Roma per arruolarsi negli Zuavi. Partecipa alla
campagna del 1867; il Pila Carocci nella sua opera La Milizia Pontifica ,
Roma Torino 1869 o annovera tra gli Zuavi distintesi tra il 1861 ed il 1868 ed
alla difesa di Roma nel 1870. Muore ad Osimo il 22 giugno 1894. Era decorato
delle medaglie Fidei Et Virtuti e Benemerenti
Fonte: Raggi P., La Nona Crociata. I Volontari di Pio
IX in difesa di Roma (1860-1870), Ravenna, Libreria Tonini, 1992
Chi avesse notizie
integrative per questa biografia è pregato di prendere contatto con il
sottoscritto.
Massimo Coltrinari.
Contatti:
massimo.coltrinari@libero.it
lunedì 3 agosto 2015
sabato 1 agosto 2015
La Campagna nelle Marche. 11 -29 settembre. I Parte
1.
PREMESSA.
Si possono comprendere e narrare le
fonti primarie e le altre testimonianze solo attraverso una rigido adempimento di
un metodo stabilito, che consiste nell’osservazione, nell’accertamento e nell’interpretazione
dei fenomeni storici. Il metodo storico quindi
deve essere impiegato come metodo di ricerca e di approfondimento per capire, come
nel caso in esame, l’unità della Nazione ed i fatti che la permisero.
a.
Avvenimento oggetto di studio.
Il tema della presente trattazione è la
campagna d’invasione nelle Marche e nell’Umbria (Scontro di Castelfidardo e
Battaglia di Ancona), svoltasi dall’11 settembre al 3 ottobre del 1860. Per
comprendere questo, come ogni altro evento storico rilevante (si pensi alla battaglia
di Canne, 216 a.C.), è necessario approfondire tutti gli avvenimenti del
Risorgimento che vanno dal 1846-48, la Repubblica Romana del 1849, la II guerra
d’Indipendenza del 1860, la battaglia del 1866 come III guerra d’Indipendenza,
fino alla presa di Roma (20 settembre 1870), vale a dire la formazione del moderno
Stato unitario italiano.
Tali avvenimenti sono alla base dell’identità
nazionale e dell’attuale modo di concepire lo Stato.
b.
Limiti di tempo e di spazio.
Il 1860 è stato giustamente definito l’anno
mirabilis del Risorgimento italiano:
in gennaio Cavour torna a guidare il governo sabaudo, nell’Italia centrale le
insurrezioni di matrice mazziniana cacciano i governi fedeli ai principi della
Restaurazione, l’Emilia e la Toscana votano plebiscitariamente l’annessione al
Piemonte, Garibaldi conquista la Sicilia e, risalendo in breve tempo le
Calabrie, il 7 settembre fa il suo ingresso a Napoli. Tale è, altresì,
considerato per i successi ottenuti dalle forze sarde nello svolgimento della
campagna dell’Umbria e delle Marche.
L’area dove si svolgono gli
avvenimenti in esame comprende le attuali province di Ancona e Macerata.
c.
Scopi e criteri.
L’assedio di Ancona del 1860 può
essere considerato come la prima operazione interforze
del costituendo Regno d’Italia. La presa della piazzaforte d’Ancona è forse uno
dei pochi esempi nella storia delle Forze Armate italiane di tutto l’800 e di
gran parte del ‘900, in cui si ritrova unità di comando, coordinazione delle
intelligenze e cooperazione di tutte le componenti delle forze impegnate in
campo, siano esse terrestri
(artiglieria, fanteria e cavalleria), che navali.
Tale campagna (1860) è fondamentale
per comprendere e interpretare i successivi avvenimenti del 1866 che
rappresentano, invece, l’esempio opposto. La mancanza di coordinazione e di
unità di intenti, tra il generale Cialdini e il generale La Marmora, comporta
la sconfitta del 24 giugno a Custoza, sebbene la tradizione unitaria italiana,
non la ricordi come tale, in quanto l’Esercito Sardo aveva ottenuto la vittoria
nelle fasi iniziali. Nella realtà dei fatti la tragedia di Custoza vede la
colonna del generale Govone mettere in fuga l’Arciduca Alberto d’Asburgo e
ridurre gli austriaci alla ritirata, ma il generale Morozzo della Rocca, non
avendo ricevuto l’ordine superiore non consente all’Esercito Italiano di sfruttare
il successo iniziale per inseguire gli austriaci e sconfiggerli. Gli stessi, vedendo
un movimento retrogrado di alcuni carreggi piemontesi, pensano che gli italiani
si stiano ritirando e perciò tornano indietro costringendo quest’ultimi ad arretrare
oltre il Mincio.
È d’obbligo a questo punto fare alcune
precisazioni poiché, spesso nelle fonti primarie, vi è una differenza tra teoria e pratica.
Senza voler fare revisionismi, né mettere in discussione ciò che è la realtà, è
necessario considerare che, se si vuole studiare correttamente il Risorgimento
d’Italia, è doveroso rivedere molte delle acquisizioni che la tradizione ci ha
tramandato, ricordando che, all’indomani delle principali tappe del 1849, del
1859 e del 1860, vengono ottenuti solo dei successi parziali nella costituzione
dello Stato unitario.
Cavour, soprattutto dopo il 1860, ha
il prioritario obiettivo di rafforzare il costituendo Stato, piuttosto che
procedere all’acquisizione di nuove terre. Per tale motivo, il Cancelliere non condivide
la Spedizione dei Mille, considerando il Meridione quasi una terra estranea all’Italia. Cavour è preoccupato
dall’acquisizione della Lombardia avvenuta nel 1859 e da quella dell’Italia
centrale (Toscana, Emilia e Romagna) dovendo procedere all’integrazione di
questi Stati nel ceppo Piemontese e nel Regno di Sardegna. Ciò rappresenta non
solo la priorità, ma anche un difficile problema, che può minare l’Unità stessa
della Penisola. È pertanto necessario dare delle disposizioni di carattere
categorico: da qui è scaturita la storiografia rinascimentale italiana che
doveva essere funzionale a costruire l’Italia unita sia come Stato, sia come Nazione.
Oggi, a 150 anni di distanza, si potrà dire ciò che realmente è avvenuto e comprendere
come i Pontifici abbiano conseguito il successo nel 1860 a Castelfidardo, guardando
semplicemente al piano d’operazioni.
2. I
BELLIGERANTI E LE ORIGINI DEL CONFLITTO.
a.
I belligeranti.
I principali belligeranti della campagna
nelle Marche e nell’Umbria sono il Regno di Sardegna e lo Stato Pontificio.
b.
Le origini del conflitto.
La II Guerra d’Indipendenza ha inizio
nel 1859, prosegue con la campagna nelle Marche e nell’Umbria dell’anno
successivo e si conclude con la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861.
Tra gli avvenimenti più importanti si
devono ricordare gli accordi segreti di Plombières con Napoleone III in
funzione antiaustriaca, l’intervento della Francia e le Battaglie di Solferino
e San Martino che segnarono, tra l’altro, la nascita della Croce Rossa ad opera
dello svizzero Henry Dunant[1].
L’armistizio di Villafranca (11 luglio
1859), voluto da Napoleone III, timoroso di una reazione prussiana sul Reno,
mentre l’esercito è interamente impegnato in Italia[2], provoca le dimissioni di Cavour che
è poi richiamato dal Re già il successivo 20 gennaio 1860, dopo una breve
parentesi di La Marmora.
Il 27 aprile 1859 il granduca Leopoldo
II lascia Firenze e viene sostituito dal Governo Provvisorio Toscano; parallelamente,
i Ducati di Parma e Modena, le Legazioni (Bologna e le città dell’Emilia e della
Romagna) si staccano dallo Stato Pontificio e formano la Lega dell’Italia Centrale,
che sarà annessa al Regno di Sardegna solo con i plebisciti dell’11 e del 12
marzo 1860.
Le Forze Armate dell’Italia centrale sono
poste sotto il comando del generale Manfredo Fanti a Firenze e del suo vice, il
generale Giuseppe Garibaldi, a Rimini. Questi concepisce, tra il dicembre 1859 ed
il gennaio 1860, un’azione su Ancona con l’intento di dirigersi a Roma, immediatamente
bloccata fermamente dal Fanti. L’obiettivo di Garibaldi sarà il fulcro intorno
cui ruoteranno tutti gli avvenimenti del 1859-60: il Partito d’Azione
Rivoluzionario vuole recarsi a Roma per abbattere il potere temporale dei papi,
mentre il governo sabaudo è più prudente, se non addirittura contrario
all’iniziativa e agisce per ritardarla. Il fermo veto di Fanti e il mancato
appoggio di Cavour e delle Grandi potenze costringono Garibaldi a dimettersi.
Il piano sarà poi ricalcato, nelle sue linee d’azione, dal IV Corpo d’Armata del generale Cialdini quando da Cattolica muoverà su Ancona pochi mesi dopo.
Il piano sarà poi ricalcato, nelle sue linee d’azione, dal IV Corpo d’Armata del generale Cialdini quando da Cattolica muoverà su Ancona pochi mesi dopo.
Intanto a Torino si progetta come
portare avanti l’unificazione della Penisola il cui passo successivo è rappresentato
dall’invasione dell’Italia centrale.
È importante ricordare che le
decisioni del Risorgimento italiano vengono prese nelle logge massoniche che
fanno capo alla Massoneria Universale, al cui vertice è posta, a quel tempo, la
Regina d’Inghilterra.
È
infatti la comune appartenenza alla Massoneria, il principale collegamento tra
Vittorio Emanuele, Garibaldi e i grandi nemici Cavour e Mazzini, uno
conservatore e l’altro progressista. Questi quattro uomini, sebbene siano
massoni e accomunati dall’ideale della Dea Ragione, frutto della rivoluzione
francese, hanno idee completamente diverse sul piano politico, per quanto
concerne le linee d’azione per giungere all’Italia unita.
È necessario comprendere che tutti gli
avvenimenti del 1860 potranno realizzarsi solo con il benestare dei Grandi del
tempo (Austria, Francia e Inghilterra). Garibaldi e i principali esponenti del
Partito d’Azione ottengono, infatti, dalla Cancelleria piementose, che auspica
per loro la medesima fine del Pisacane, il consenso politico per lo svolgimento
della Spedizione nel Meridione[3].
La spedizione dei Mille, autorizzata
dal governo sabaudo, ha il principale obiettivo di allontanare Garibaldi ed
impedirgli di portare avanti ulteriori azioni nel centro Italia. L’iniziativa
garibaldina, contrariamente a quanto auspicato da Cavour, ha successo, ancorché
il contingente parta, il 4 maggio da Quarto, armato solo di vecchi fucili e
privi di munizioni e polvere da sparo. Dopo una breve sosta a Talamone, determinata
dalla necessità di rifornirsi di munizioni, Garibaldi giunge l’11 maggio 1860, sotto
la protezione della Flotta del Persano e di quella inglese, sulle coste
siciliane e sbarca a Marsala. Il 15 maggio 1860, in località Pianto
Romano, a poca distanza dall'abitato di Calatafimi, i Mille si trovano di
fronte otto battaglioni Cacciatori ed altre truppe borboniche al comando del
generale Landi[4]. Il primo attacco, dai piedi della
collina, è portato dai trenta Carabinieri genovesi armati di carabina, per
colpire gli ufficiali avversari e quindi scardinare l’azione di comando (azione
che sarà ripetuta anche a Castelfidardo). Ma la sorte non sembra essere
favorevole alle “camicie rosse”, lo stesso Bandi, segretario di Garibaldi,
gravemente ferito, si aspettava il colpo di grazia da parte delle forze borboniche.
Verso le cinque di sera, dopo aver
respinto ripetuti assalti da parte delle ben preparate e meglio armate truppe
borboniche, i garibaldini, praticamente sconfitti, si preparano a ripiegare, quando
il generale Landi dà ordine alle truppe borboniche di fare ritorno agli
acquartieramenti. I contadini, che assistono dalle colline all’andamento della
battaglia, vedendo i borbonici “ritirarsi” e quei pochi garibaldini superstiti
avviarsi verso la cima della collina, decretano la vittoria di Garibaldi e si uniscono
quindi alle sue truppe.
La campagna di Garibaldi nel Meridione
procede favorevolmente al contrario delle aspettative della Cancelleria
torinese. In quei primi giorni di operazioni Giuseppe Garibaldi assume la dittatura
della Sicilia in nome di Vittorio Emanuele con l’Editto di
Salemi, facendone la prima capitale del Regno d’Italia, anche se per un sol
giorno. La presa di Palermo del 27 maggio, attraverso il Ponte
dell’Ammiragliato, segna il primo vero successo militare della Spedizione dei
Mille e pone le basi per la conquista di tutta l'Italia Meridionale. Nella
battaglia di Palermo i trentamila Borbonici restano nelle Caserme e i 2200
Garibaldini non trovano praticamente resistenza, in quanto l’anziano generale
Lanza credendoli attestati a Corleone non da l’ordine ai soldati di intervenire.
Il Bandi descrive nelle sue pagine la campagna di Sicilia ed i rapporti
esistenti tra il console inglese, la flotta inglese, la massoneria ed i
proprietari inglesi che vogliono l’allontanamento dei Borboni ostili ai loro commerci
(si pensi che il vino marsala, era ricercatissimo sulle tavole di Londra).
La sconfitta delle truppe borboniche il
20 luglio
a Milazzo e la neutralizzazione di Messina, pongono
i presupposti per dare inizio ai preparativi di passaggio sul continente. La Sicilia
è dunque conquistata, il 3 settembre 1860 l’esercito di Garibaldi attraversa lo
Stretto ed il Generale giunge a Napoli il 7 settembre in carrozza e senza
scorta.
Ai napoletani plaudenti su via Toledo Garibaldi
comunica che non si fermerà a Napoli, ma vuole immediatamente proseguire per
raggiungere il suo principale obiettivo, la presa di Roma.
Allo stato dei fatti, il reale
pericolo per il progetto cavouriano è rappresentato dall’azione di Garibaldi.
3. LA
SITUAZIONE GENERALE.
- Le
Istituzioni militari pontificie (1849-1860).
Fin qui è stato rappresentato il
quadro generale, ma è tuttavia necessario comprendere anche chi siano gli
antagonisti della Cancelleria sabauda. A Roma vi è naturalmente il papa Pio IX,
le cui istituzioni militari pontificie dal 1849 al 1860 sono state
profondamente ristrutturate. La Repubblica Romana è tramontata, sono ritornati
i cardinali tra cui i della Gancia che restaurano il potere temporale dei papi
e con 8000 uomini ricostituiscono l’Esercito pontificio. Esso si trasforma prima
nel 1850 con i Veliti pontifici, diventati poi gendarmi e, ancora, nel 1852 con
la riforma Kellerman, che mette a punto un esercito pienamente capace di
svolgere l’incarico più importante: mantenere l’ordine pubblico e tenere testa
ad ogni rivoluzione. Quindi, nel 1860 si costituisce il cosiddetto esercito di
de La Moriciere[5], che combatterà a Castelfidardo,
successivamente ristrutturato dal de Merode[6].
Dopo gli eventi della campagna delle
Marche e dell’Umbria è necessario ricordare la battaglia di Mentana (3 novembre
1867), dove le truppe pontificie al comando del generale Kanzler sconfiggono i garibaldini,
assicurando altri tre anni di vita allo Stato pontificio. È in tale contesto
che si colloca la vicenda, raccontata nelle pagine del Bandi, dei fucili Chassepot[7], utilizzata per nascondere invece la
sconfitta dell’esercito garibaldino. Il Chassepot è un fucile a retrocarica ad
ago di prima generazione, che tuttavia riusciva a sparare solo due salve,
dopodiché l’ago si deformava, tanto che fu ritirato qualche mese dopo. Tali
fucili, inoltre, non diedero bella prova nemmeno nel 1870 contro i tedeschi
durante la campagna di Sedan.
L’esercito del Kanzler è infine sciolto
il 21 settembre 1870 con la solenne benedizione papale in piazza San Pietro. Da
allora restano solo i 147 elementi della Guardia Svizzera, risalenti a papa
Giulio II, la Guardia Nobile e la gendarmeria. Ancor oggi, infatti, lo Stato
pontificio ha le proprie forze armate che mantengono le tradizione dell’Esercito
pontificio e di cui viene conservata memoria presso il museo di San Giovanni in
Laterano.
(1)
L’esercito del de La Moriciere.
L’esercito di de La Moriciere[8] che va dall’8 aprile al 3 ottobre del
1860, termine della campagna in esame, è organizzato su tre brigate operative
ed una brigata di riserva, ma soprattutto si incardina su di un dispositivo stanziale
basato su gendarmerie e piazzeforti, le cui principali sono Roma ed Ancona.
Roma è logicamente la sede, mentre Ancona garantisce i collegamenti con Trieste
e l’Austria. Il dispositivo si compone anche di piazze di seconda classe, come
quella di Castel Sant’Angelo a Roma, e quelle presso le principali città
dell’Umbria e delle Marche, che garantiscono il punto di appoggio per la
manovra ed il sostegno logistico delle brigate operative.
Il de La Moriciere l’8 aprile 1860,
con il patrimonio del de Merode istituisce cinque battaglioni bersaglieri
procedendo al reclutamento soprattutto di croati, sloveni e tedeschi perché animati
da un forte sentimento anti-italiano. Queste unità reclutate al doppio del
soldo, dal Nunzio a Vienna e dal co-nunzio a Trieste vengono imbarcate alla
volta di Ancona e, quindi, instradate verso Foligno o Perugia. Il de La
Moriciere riesce a costituire, nel giro di tre mesi, cinque battaglioni
bersaglieri di cui uno prenderà poi parte allo scontro di Castelfidardo. Istituisce,
altresì, il corpo dei tiragliatori franco-belgi che diventerà poi il
battaglione degli zuavi pontifici. Questi sono dei legittimisti francesi e
belgi (spesso nobili di nascita) che combattono per il Papa, ma non volendo
entrare nel reggimento esteri si danno ordinamento in un distinto battaglione,
che il 1° gennaio del 1861 adotta l’uniforme zuava, che ricorda poi quella
francese e coloniale. Le truppe pontificie hanno tra le proprie file anche il
battaglione San Patrizio, composto da volontari provenienti dall’Irlanda, spinti
dall’estrema povertà che impone, quale alternativa all’emigrazione in America, la
possibilità di arruolarsi nell’Esercito del Papa. La loro uniforme non ha zaino
e buffetterie, ma dei larghi pantaloni dove si ripone l’occorrente.
Un’unità d’eccellenza dell’Esercito
pontificio è il battaglione Carabinieri svizzeri, specializzato nel tiro di precisione
con la carabina i cui componenti sono reclutati con gli stessi metodi della
Guardia Svizzera. I Carabinieri pontifici sono elementi eccellenti, come
dimostrato a Castelfidardo, che risultano fondamentali per il conseguimento del
successo nella prima parte dei combattimenti. In ultimo, le Guide di de La
Moriciere, cavalleria composta da nobili, costituita da circa 80 elementi che si muove con tutto
l’equipaggiamento al seguito.
L’esercito pontificio è strutturato
per contenere la rivoluzione, come dimostra l’episodio delle stragi di Perugia[9], e quindi esercitare pienamente il
controllo del territorio.
(2)
I Capi dell’esercito del de La
Moriciere.
I protagonisti sono il de La Moriciere
stesso ed il generale G. de Pimodan ex colonnello francese, sepolto a San Luigi
dei Francesi. Morto a Castelfidardo nell’ottobre del 1860, è divenuto il
simbolo e il martire della difesa dei diritti della Chiesa contro la
rivoluzione, la massoneria e i nemici di Pio IX.
4. LA
SITUAZIONE PARTICOLARE.
- La
battaglia delle Grotte di Castro (19 maggio 1860).
Ne corso della spedizione dei Mille,
Garibaldi contravvenendo agli ordini di Mazzini e soprattutto del Controllore
piemontese, sbarca a Talamone un contingente di 60 rivoluzionari che, al
comando dello Zanbianchi, reduce della Repubblica Romana e animato da un forte
sentimento anticlericale, tenta di portare la Rivoluzione nello Stato
Pontificio e direttamente nel Lazio. I 60 garibaldini, grazie ad ottime
informazioni, vengono individuati e attaccati dalla brigata del de Pimodan alle
Grotte di Castro il 19 maggio 1860 e, nel giro di tre ore, vengono inseguiti e
circondati. Durante gli scontri con le forze regolari pontificie vengono uccisi
19 uomini, mentre gli altri riguadagnano il confine, ma vengono poi arrestati e
condotti in fortezza a Bardonecchia dalle truppe sarde su ordine del Governo
piemontese. Tale episodio dimostra che l’Esercito pontificio è ben preparato e
addestrato alla difesa dello Stato ed al controllo del territorio, ma
soprattutto eccelle nella lotta contro rivoluzionaria.
- I
protagonisti.
Pio IX[10], dei Mastai Ferretti (1792-1878),
nato a Senigallia e legato alle famiglie marchigiane dei Castelferetti, già in
giovane età è iscritto alla massoneria, ma per volere della famiglia viene
mandato in seminario. Fu eletto Papa in quanto il vero candidato, il cardinale Tommaso
Gizzi[11] “non giunse in
tempo per il conclave”.
Il Conclave decise allora per l’elezione del cardinale Mastai nella convinzione che fosse dotato di scarsa personalità e potesse essere facilmente condizionabile. Tale convinzione, invece, si rivelò ben presto errata. Il rapporto di Pio IX con il regno delle due Sicilie di Francesco II può dirsi formidabile e molto stretto, difatti, quando il Papa si rifugia a Gaeta dal 1848 al 1850 è lo stesso Francesco II che lo protegge.
Il Conclave decise allora per l’elezione del cardinale Mastai nella convinzione che fosse dotato di scarsa personalità e potesse essere facilmente condizionabile. Tale convinzione, invece, si rivelò ben presto errata. Il rapporto di Pio IX con il regno delle due Sicilie di Francesco II può dirsi formidabile e molto stretto, difatti, quando il Papa si rifugia a Gaeta dal 1848 al 1850 è lo stesso Francesco II che lo protegge.
Ma la vera “anima nera” del governo
pontificio in quel tempo è il cardinale Giacomo Antonelli[12] che rappresenta la Chiesa del passato
che si scontra con la realtà del presente. Il cardinale Antonelli è una figura
estremamente significativa del tempo e degli avvenimenti che seguirono.
Sul fronte opposto c’è il generale Manfredo
Fanti (1806-1865), fondatore dell’Esercito Italiano, che mise la firma sul decreto
che trasformava l’Armata sarda in Esercito Italiano il 4 maggio 1861. Il Fanti si
è formato sui campi di battaglia, dopo le sommosse del 1832 a Modena, con Cialdini,
Durant ed altri prende parte alle guerre spagnole. Un’altra figura centrale del
Risorgimento italiano è il generale Enrico Cialdini[13], già colonnello dell’esercito pontificio,
ferito a Cornuda, nel 1849 entra a far parte dell’Esercito sardo, comandante del
23° Reggimento a la Cava[14] (20 marzo 1849) resiste allo stremo,
ma alla fine è circondato e si arrende.
È interessante notare come la vita
militare di questi personaggi del Risorgimento italiano sia caratterizzata dai
medesimi problemi operativi (mancanza di informazioni sui movimenti e le
posizioni del nemico), logistici (scarsità di risorse) e soprattutto di carenza
di bilancio, che oggigiorno assillano le F.A. italiane. Le lettere di questi
Ufficiali dimostrano come hanno affrontato i loro problemi e li hanno risolti,
rappresentando un riferimento anche per le situazioni attuali.
I veri protagonisti di queste vicende,
le figure di riferimento del Risorgimento italiano, che tengono le file sia
politiche, che militari sono il re Vittorio Emanuele II, Cavour, Mazzini e
Garibaldi che, nonostante l’iconografia popolare voglia veder agire per un
unico scopo in qualità di “Padri della Patria”, sono in sostanza perennemente
in lotta tra loro, animati sia da scopi ed intenti spesso contrastanti, sia da
rivalità ed antipatie personali.
- Avvenimenti
e provvedimenti in vista del conflitto.
È opportuno, tuttavia, comprendere
quali siano i processi decisionali che portano all’Unità d’Italia e all’avvio
della campagna delle Marche e dell’Umbria del 1860.
I protagonisti, a dispetto delle profonde rivalità e delle diverse prospettive politiche, sono accomunati dall’obiettivo politico-militare di ricondurre l’intera Penisola sotto un’unica Autorità governativa e, quindi, di eliminare il potere temporale del Papa che grava sulla collettività dell’Italia centrale.
I protagonisti, a dispetto delle profonde rivalità e delle diverse prospettive politiche, sono accomunati dall’obiettivo politico-militare di ricondurre l’intera Penisola sotto un’unica Autorità governativa e, quindi, di eliminare il potere temporale del Papa che grava sulla collettività dell’Italia centrale.
Il Cavour, nella sua visione politica
di costruzione dell’Unità nazionale, è restio ad intraprendere azioni nel
centro Italia e nell’Umbria in particolare. Il suo timore è che un’ulteriore
annessione dei territori dell’Italia centrale possa compromette l’equilibrio
dell’intero progetto e farlo definitivamente naufragare. Di contro, Mazzini è dell’idea
opposta, preme affinché la Rivoluzione venga portata ovunque dal Partito
d’Azione, nella convinzione che la spinta destabilizzante agevoli i progetti di
unificazione dello Stato. Garibaldi, da uomo d’azione quale è, preme per
riprendere le operazioni, ma viene di fatto distratto dal centro Italia con la Spedizione
dei Mille nel Mezzogiorno. Infine, il re Vittorio Emanuele II, quale elemento
centrale di riferimento, si trova nella difficile condizione di dover gestire
la situazione sia per dare coerenza alle molteplici azioni, sia perché tutti i
personaggi agiscono per suo nome e conto.
Per Cavour e, quindi il Re, i progetti
di Mazzini e Garibaldi possono mettere in discussione gli equilibri dell’intera
Europa, soprattutto un’eventuale costituzione di una repubblica di stampo
“mazziniano” al centro del Mediterraneo è uno scenario assolutamente non accettabile
dalle principali Potenze (Inghilterra, Francia e Austria). Questo rappresenta
il punto centrale della questione a quel tempo. Il progetto di Mazzini e
Garibaldi, quest’ultimo già arrivato a Napoli con i Mille, prevede di entrare a
Roma, rovesciare il papato e ricostituire una repubblica sul modello di quella
Romana del 1849. È opportuno ricordare che la Repubblica Romana è stata
caratterizzata da una costituzione assolutamente innovativa per l’epoca: consentiva,
ad esempio, il diritto di voto alle donne, il divorzio e l’aborto.
Di fronte a questo pericolo reale, rappresentato dalle idee e dalle azioni del Mazzini e Garibaldi, le grandi Potenze devono intervenire per non vedere compromesso lo status quo. L’Austria, tuttavia, affronta pesanti problemi in Oriente ed in Romania, la Francia è scossa al suo interno per le lotte tra Conservatori, Cattolici e Progressisti e l’Inghilterra, da ultima, non è in una situazione migliore. La Guerra Civile Americana (1860-65) vede, altresì, impegnate fortemente sia la Francia, che l’Inghilterra nel tentativo di riguadagnare una certa influenza sul continente americano. In questo quadro generale alquanto instabile si inserisce, appunto, anche la situazione italiana che fino ad allora non ha posto particolari preoccupazioni ai principali Attori dell’epoca.
Di fronte a questo pericolo reale, rappresentato dalle idee e dalle azioni del Mazzini e Garibaldi, le grandi Potenze devono intervenire per non vedere compromesso lo status quo. L’Austria, tuttavia, affronta pesanti problemi in Oriente ed in Romania, la Francia è scossa al suo interno per le lotte tra Conservatori, Cattolici e Progressisti e l’Inghilterra, da ultima, non è in una situazione migliore. La Guerra Civile Americana (1860-65) vede, altresì, impegnate fortemente sia la Francia, che l’Inghilterra nel tentativo di riguadagnare una certa influenza sul continente americano. In questo quadro generale alquanto instabile si inserisce, appunto, anche la situazione italiana che fino ad allora non ha posto particolari preoccupazioni ai principali Attori dell’epoca.
L’occasione comunque viene colta da Napoleone
III che, a causa delle tensioni interne con i Cattolici, intravede un’opportunità
per ridimensionarne il potere in Francia e indebolire il potere di Pio IX. La
proposta di Cavour di agire nel centro Italia è l’occasione favorevole per
ridurre lo stato della Chiesa al solo Patrimonio di San Pietro (Lazio), ma
contemporaneamente di sfruttare la situazione per obbligare il Papa a
intervenire in suo favore e contenere i Cattolici in Francia. La Cancelleria
sabauda, parimenti, deve entrare nelle Marche e nell’Umbria per raggiungere il
Meridione e porre un freno a Garibaldi che intanto sta risalendo vittorioso la
Penisola. Le Grandi potenze hanno, infatti, necessità di ricondurre la
Rivoluzione mazziniana in un alveo più moderato e conservatore per non
destabilizzare l’intera Penisola e la situazione esistente.
L’unico in grado, al momento, di
intervenire in Italia centrale è Cavour che può disporre dell’esercito di
Vittorio Emanuele II. L’Austria da parte sua si trova in una situazione d’impasse: un intervento contro il Regno
di Sardegna significherebbe riaprire il fronte sul Mincio (I Guerra
d’Indipendenza), contrariamente lasciare mano libera a Cavour equivarrebbe ad offrirgli
l’opportunità di conquistare l’Italia centrale.
L’Inghilterra, dal canto suo, non gradisce
la costituzione di una repubblica
progressista nell’alveo europeo, ma potrebbe accogliere favorevolmente
un ridimensionamento dell’influenza francese ed austriaca nella penisola
italiana e la costituzione di uno Stato unitario guidato dal massone Cavour e da
Vittorio Emanuele II più facilmente controllabile. Il principale e forse unico
obiettivo dell’Inghilterra è rappresentato dalla necessità di mantenere la
propria libertà sulle rotte commerciali del Mediterraneo e, con un’Italia unita
e amica, di fatto potrebbe esercitare il controllo su tali rotte marittime.
Alla fine di agosto del 1860, una
delegazione del Regno di Sardegna composta dal generale Cialdini e dal generale
Farini si reca a Chambery, per incontrare Napoleone III e metterlo a conoscenza
dell’intenzione di scendere in bassa Italia e ricondurre Garibaldi sotto il
controllo della politica del Cavour, impedendogli di fatto di giungere a Roma. Con
tale progetto il Cavour propone la creazione di un grande Stato italiano legato
alla Francia, in considerazione della gratitudine per l’intervento a proprio
favore. Napoleone III, a cui piace la proposta piemontese, tuttavia si vede
costretto a non accettare a causa delle forti pressioni avanzate dal partito
Cattolico rappresentato dalla moglie che interferisce con la politica
dell’Imperatore. In tale occasione comunque Napoleone III, pur non potendosi esprimere
a favore dell’iniziativa non la contrasta e, di fatto, autorizza tacitamente
l’azione del Regno di Sardegna[15]. In tale frangente il Cavour,
ricevendo le rassicurazioni di non intervento di Francia e Austria, ha di fatto
mano libera nelle Marche e nell’Umbria, per andare incontro a Garibaldi e
impedirgli di portare a termine la propria campagna nel Sud d’Italia.
- I
piani operativi.
Importante per comprendere lo
svolgimento degli eventi è guardare agli atteggiamenti della diplomazia
pontificia. PIO IX e il cardinale Antonelli non sembrano intuire la gravità
della situazione, anzi sono convinti che la principale minaccia provenga dalla
campagna di Garibaldi nel Sud d’Italia e che, in caso di una invasione da parte
dell’esercito di Vittorio Emanuele II, la Francia intervenga a loro favore. A
tal proposito, anche il de La Moriciere è convinto che il pericolo maggiore
provenga dalla bassa Italia e lo dimostra il fatto che il grosso del
dispositivo militare pontificio sia schierato ed orientato a Sud.
I francesi sono disposti all’interno
del Patrimonio di San Pietro, il de La Moriciere con le tre Brigate operative
sull’asse Terni–Spoleto–Foligno ed il de Courten su Ancona per mantenere i
collegamenti marittimi con Trieste e l’Austria. Sul fronte Nord dello Stato
pontificio invece non c’è praticamente nulla.
Nel gioco delle grandi Potenze il
Regno di Sardegna ottiene il sostanziale via libera per invadere l’Italia
centrale e scendere nel Meridione.
Cavour rimane comunque molto scettico,
se non contrario, sull’opportunità di dare corso all’iniziativa nelle Marche e
nell’Umbria, ma il Re si impone e affida il comando dell’Esercito al generale Fanti
con l’ordine di preparare il piano di invasione che comprende anche l’obiettivo
occulto di fermare Garibaldi.
Il 7 settembre 1860, per il tramite del Conte della Minerva, è inviato da Torino un ultimatum a Roma, che, a causa di una tempesta nell’alto Tirreno, giunge il giorno successivo e viene immediatamente respinto dal Antonelli.
Sono giorni estremamente difficili per il Cancelliere piemontese. Gli ambasciatori di Russia, Francia, Austria e Inghilterra vengono ritirati da Torino lasciando, almeno per alcuni giorni, il Regno di Sardegna formalmente isolato diplomaticamente. Ciò fa temere la Cancelleria piemontese che ci sia un cambiamento di fronte delle Potenze europee e, quindi, che venga a mancare il promesso appoggio politico all’iniziativa piemontese. Contestualmente al rifiuto dell’ultimatum da parte dell’Antonelli, due reggimenti francesi si imbarcano a Tolone l’8 settembre. Tale evento è differentemente interpretato dai due protagonisti. Per l’Antonelli, Napoleone III viene in soccorso, mentre per il Cavour significa che la Francia mantiene le promesse date, assicurandosi esclusivamente che il Lazio resti a Pio IX.
Il 7 settembre 1860, per il tramite del Conte della Minerva, è inviato da Torino un ultimatum a Roma, che, a causa di una tempesta nell’alto Tirreno, giunge il giorno successivo e viene immediatamente respinto dal Antonelli.
Sono giorni estremamente difficili per il Cancelliere piemontese. Gli ambasciatori di Russia, Francia, Austria e Inghilterra vengono ritirati da Torino lasciando, almeno per alcuni giorni, il Regno di Sardegna formalmente isolato diplomaticamente. Ciò fa temere la Cancelleria piemontese che ci sia un cambiamento di fronte delle Potenze europee e, quindi, che venga a mancare il promesso appoggio politico all’iniziativa piemontese. Contestualmente al rifiuto dell’ultimatum da parte dell’Antonelli, due reggimenti francesi si imbarcano a Tolone l’8 settembre. Tale evento è differentemente interpretato dai due protagonisti. Per l’Antonelli, Napoleone III viene in soccorso, mentre per il Cavour significa che la Francia mantiene le promesse date, assicurandosi esclusivamente che il Lazio resti a Pio IX.
Il piano di invasione piemontese
prevede lo schieramento di due Corpi d’Armata sardi nella Romagna esattamente nell’area
ad Ovest di Rimini per muovere verso Ancona secondo due direttrici parallele.
La prima esterna, con il IV Corpo d’Armata al comando del generale Cialdini,
marcia lungo la costa adriatica; quella interna, del V Corpo d’Armata, al
comando del generale Enrico Morozzo della Rocca, secondo l’ordine di Fanti,
marcia verso Perugia lungo l’asse San Sepolcro, Foligno, Perugia, Spoleto, Terni,
cioè lungo l’asse dove era schierato l’Esercito pontificio.
Il generale Fanti, comandante delle truppe
piemontesi, si ripromette di muovere con il IV Corpo d'Armata (la sinistra) lungo l'Adriatico, per
attirare il nemico verso Ancona. Il V Corpo (la destra) deve intanto avanzare
verso la valle del Tevere e tagliare la ritirata su Roma all'esercito
pontificio che, in tal modo, sarebbe costretto a dare battaglia in condizioni
di netta inferiorità numerica. Per tale motivo, nella convinzione che l’Esercito
pontificio rimanga schierato in Umbria per mantenersi alle spalle la base
logistica della piazza di Roma, viene dato, nell’assegnazione delle forze,
maggiore peso al V Corpo d’Armata. Questo rappresenta uno dei primi errori di
valutazione strategica dell’Esercito piemontese, a cui purtroppo ne seguono
altri di natura tattica, sebbene l’esito della campagna risulterà favorevole al
Regno di Sardegna.
La Reale flotta Sarda, al comando
dell’ammiraglio Carlo Pellion di Persano, si deve portare di fronte ad Ancona
per imporre il blocco del porto e condurre cannoneggiamenti contro la
piazzaforte. Il Persano sarà poi il protagonista della battaglia di Lissa (1866)
che lo vedrà soccombere alla flotta austriaca, principalmente a causa della
scarsa amalgama della neo costituita flotta del Regno d’Italia con quella
ex-pontificia e quella ex-borbonica al comando dell’ammiraglio Artun.
- Le
forze in campo.
Le forze Sarde, che in quel momento
stanno marciando dalla Romagna verso il centro Italia, sono costituite da 35
mila uomini, 2500 cavalli e 77 pezzi d'artiglieria. La restante parte dell’Esercito
Sardo, costituito da 82 mila unità, è già schierato lungo il Mincio in funzione
di sicurezza. Le forze al comando del generale Fanti (IV Corpo d’Armata
composto dalla 4a e dalla 7a Divisione) marciano al
centro, quelle del generale Cialdini (V Corpo d’Armata composto dalla 1a
Divisione e dalla Divisione di riserva), muove lungo la litoranea adriatica ed
il collegamento tra i due corpi d’armata è costituito dalla 13a
Divisione al comando del generale Raffaele Cadorna, che poi guiderà la presa di
Roma. L’importanza della 13a Divisione risiede nel fatto che deve
supportare le azioni rivoluzionarie diversive che i patrioti innescheranno il
9, 10 e l’11 di settembre nel Nord delle Marche presso Pergola e Fossombrone,
con lo scopo di attirare le forze delle guarnigioni pontificie al di fuori
delle piazzeforti.
Il piano operativo delle forze
pontificie, al comando del generale de La Moriciere con il quartier generale a
Spoleto, è composto dalla Brigata Schmidt a Foligno, una seconda Brigata a
Terni sotto il de Pimodan e la Brigata riserva Cropt a Spoleto.
Su Ancona invece staziona la terza Brigata agli ordini di de Courten.
Su Ancona invece staziona la terza Brigata agli ordini di de Courten.
L’essenza del piano operativo risiede
nel dislocamento delle truppe francesi a presidio di Roma, per garantire la
sicurezza della piazza principale ed il grosso delle truppe schierate al centro,
in maniera tale da poter muovere più agevolmente e poter difendere sia il Lazio,
che le Marche. Il piano dispositivo prevede appunto le forze migliori (terza Brigata
operativa) a Sud perché da lì, ritengono, possa concretizzarsi la minaccia. Tutto
il dispositivo pontificio delle Forze Mobili è infatti orientato verso Sud.
Per ciò che riguarda le istallazioni
fisse, risulta d’importanza strategica per l’Esercito pontificio mantenere
aperti i porti ed i collegamenti con Ancona e Civitavecchia per consentire, in
caso di attacco da parte del Regno Sardo, l’arrivo di forze delle potenze amiche
di Austria e Francia che sarebbero certamente intervenute.
La piazzaforte di Ancona, collegata attraverso Colfiorito, lungo la strada postale Roma–Ancona, è in grado di mantenere e garantire le comunicazioni con l’Austria, mentre i collegamenti con la Francia sono assicurati tramite il porto di Civitavecchia. I numeri delle forze dell’Esercito pontificio consistono in circa 8500 uomini delle Forze Mobili e 7000-7500 nelle piazzeforti per un totale di circa 16 mila uomini, molto ben preparati anche grazie all’impegno del de La Moriciere che ha costituito un dispositivo estremamente efficace.
La piazzaforte di Ancona, collegata attraverso Colfiorito, lungo la strada postale Roma–Ancona, è in grado di mantenere e garantire le comunicazioni con l’Austria, mentre i collegamenti con la Francia sono assicurati tramite il porto di Civitavecchia. I numeri delle forze dell’Esercito pontificio consistono in circa 8500 uomini delle Forze Mobili e 7000-7500 nelle piazzeforti per un totale di circa 16 mila uomini, molto ben preparati anche grazie all’impegno del de La Moriciere che ha costituito un dispositivo estremamente efficace.
[1] Le atrocità e gli
orrori del campo di battaglia di Solferino e Castiglione delle Stiviere,
cittadina presso la quale iniziò la grande battaglia del 24 giugno 1859,
ispirarono i criteri umanitari per il recupero e la cura del ferito. In quei
tempi erano infatti più numerose le perdite di uomini causate da setticemie e
infezioni dopo gli scontri, che quelle durante la battaglia. Tuttavia,
l’esigenza era anche militare, di natura tattica, essendo gli eserciti
post-napoleonici caratterizzati per la volontarietà e professionalità dei
componenti, per cui il recupero degli uomini feriti era indispensabile nel
corso del conflitto per curarli ed evitare quindi la falcidia di caduti dopo la
battaglia.
[2] Furono anche le
grandi tragedie francesi a Solferino, con quattro comandanti di reggimento
morti sul campo, a motivare il ritiro della Francia.
[3] Carlo Pisacane nel 1857 con 300 uomini tenta
di portare la Rivoluzione
nel napoletano e nel Sud, ma muore sotto le forcole per mano dei contadini.
Pisacane è stato uno dei massimi pensatori militari italiani dell’800, uno dei
migliori prodotti dell’istituto militare La Nunziatella che era
una fonte primaria di studi militari dell’epoca. Le sue idee innovative hanno influenzato tutta la seconda
metà del XIX secolo.
[4] Le truppe borboniche erano ben piazzate sulle alture del
colle, in posizione favorevole, ottimamente armate e supportate da due moderni
pezzi di artiglieria da campagna ed un reparto di cavalleria. All'opposto, i garibaldini
si trovavano nelle posizioni sottostanti, senza l'appoggio di cavalleria e
dotati di armamenti superati e fatiscenti.
[5] Christophe
L.L.J. de La Moriciere
è nominato nel 1830
capitano degli Zuavi
e nello stesso anno partecipa alla spedizione d'Algeria. Diviene
colonnello nel 1837.
Nel 1843 viene
nominato generale di divisione. Nel 1860 si mette a disposizione dell'esercito pontificio dove tenta
invano di opporsi all'invasione delle Marche e dell'Umbria da parte
dell'esercito sabaudo. A seguito della sconfitta di Castelfidardo, rientra quindi in Francia
per finire i suoi giorni nel suo castello di Prouzel.
[6] Saverio de Merode, (Pro-Ministro delle Armi
dello Stato pontificio dal 1860 al 1865), è stato tenente belga ed ha
combattuto in Africa inquadrato nella Legione straniera. Nel 1848 scelse però la
carriera ecclesiastica: prese gli ordini e, caduta la breve Repubblica romana del 1849, partecipò
attivamente alla restaurazione dello Stato
pontificio. Divenuto cardinale, ha riformato l’Esercito pontificio con il
proprio patrimonio personale, facendo costruire numerose caserme tra cui la Pio IX riadattando inoltre
palazzo Salviati.
[7] Chassepot è il
nome di un'arma individuale in dotazione all'esercito francese nella seconda
metà del XIX secolo. È uno dei primi fucili a retrocarica utilizzati in
operazioni di larga scala.
Prese il nome da Antoine-Alphonse
Chassepot (1833–1905), l'inventore del sistema d'otturazione gomma che lo
equipaggiava. Il Chassepot consentiva una portata utile fino a 1300 metri poiché il
proiettile usciva con un terzo della velocità in più, migliorando precisione e
penetrazione.
L'esercito francese che sbarrò la
strada alla spedizione garibaldina per annettere Roma all'Italia e la sconfisse
nella battaglia di Mentana era equipaggiato con quest'arma. I francesi ebbero
facilmente ragione dei garibaldini, equipaggiati invece con obsolete armi ad
avancarica: il comandante francese, al termine dello scontro, commentò: "I
nostri Chassepot hanno fatto meraviglie".
Il fucile fu rimpiazzato nel 1874 dal
fucile Gras, che era capace di trattenere una cartuccia fatta di metallo e non
di carta, come nel Chassepot. Tutti i Chassepot ancora in uso vennero
convertiti per accettare la stessa cartuccia (fusil modèle 1866/74).
[8] De la Moriciere è ufficiale
francese, forte oppositore di Napoleone III già dal 1848. È divenuto generale
durante le campagne d’Africa ed è stato l’eroe di Costantina che per manovra e
per assalti è riuscito ad espugnare. È ricordato, altresì, per aver istituito
il corpo militare dei Tuareg, le truppe celeri, equivalente coloniale dei
bersaglieri italiani.
[9] Perugia insorse al
potere papale il 14 giugno 1859 quando instaurò un governo provvisorio. Il
legato pontificio dovette fare ritorno a Roma e lo Stato della Chiesa reagì in
maniera dura, ordinando la repressione dei moti ed inviando duemila guardie
svizzere comandate dal colonnello Schmidt. Il segretario di stato di Pio IX, il
cardinale Antonelli, autorizzò al saccheggio della città le truppe svizzere
inviate per riportare entro i confini del dominio della Chiesa la città
perugina: il 20 giugno 1859 questi entrarono in città e fecero strage dei rivoltosi,
senza risparmiare donne e bambini. L'evento passò alla storia come le “stragi
di Perugia”
[10] Pio IX, terziario
francescano, è stato il 255° vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica
(1846-1878): è stato proclamato beato nel 2000. Il suo pontificato, di 31 anni,
7 mesi e 23 giorni, rimane il più lungo della storia della Chiesa cattolica,
dopo quello di san Pietro.
[11] Tommaso Pasquale Gizzi, appartenente all'ala riformista
moderata della Curia romana, godeva di grande popolarità, tanto da
essere considerato tra i papabili nel Conclave del 1846, nel quale
raccolse inizialmente numerosi voti; nelle successive votazioni tuttavia le
preferenze dei Cardinali si rivolsero al cardinal Giovanni Maria Mastai
Ferretti che, eletto Papa
col nome di Pio IX,
lo nominò Segretario di Stato l'8 agosto 1846. Gizzi tuttavia si
dimise l'estate successiva, il 17 luglio 1847. Gli successe il cardinal Gabriele
Ferretti, cugino del Papa. Morì il 3 giugno 1849, a Lenola, all'età di
61 anni.
[12] Giacomo Antonelli di origine umilissime, appena
ordinato diacono, fu voluto da Papa Gregorio XVI
fra i propri collaboratori. Tale decisione segnò la vita di Antonelli. A 22
anni egli divenne assessore presso una delle sezioni di giudizio penale della provincia di
Roma e, con rapidissima carriera, fu nominato delegato
a Orvieto,
poi a Viterbo
e, infine, a Macerata.
Nel 1841
fu nominato sottosegretario agli interni, quale vice del cardinale Mattei, nel 1845 fu Grande Tesoriere,
ovvero Ministro delle Finanze. Dopo la restaurazione del potere papale, il 15
luglio 1849,
grazie all’intervento francese, Antonelli tornò a Roma con il Papa Pio IX, fu
posto alla guida del neocostituito Consiglio di Stato. Egli riorganizzò
l’amministrazione, perseguitò i suoi avversari politici e introdusse, in modo
deciso e astuto, un regime assolutistico di polizia.
[13] Enrico Cialdini, generale
e politico italiano del Risorgimento, combatté contro i Carlisti in Spagna, come il conterraneo
Manfredo
Fanti, col grado di colonnello. Rientrato in Italia nel 1848, nel corso della Prima Guerra d'Indipendenza,
prese parte sia alla Seconda, sia alla Terza. Fu eletto deputato al primo (1860) ed al secondo (1861) parlamento
italiano; quindi, nel 1864
divenne senatore. Dal 1869 al 1881, anno in cui si ritirò definitivamente dalla
vita politica, fu ambasciatore prima in Spagna, quindi in Francia.
[14] Il 20
marzo 1849 il Re Carlo Alberto riprende la Guerra per liberare la Lombardia dall'Austria e
crede di liberare Milano muovendo da Trecate, varcando il Ticino al Ponte di
Buffalora verso Magenta; invece è il Radetzky che prende l'iniziativa da Pavia,
forzando il confine col Piemonte al Gravellone di S. Martino Siccomario e di
qui irrompendo per tutta la
Lomellina.
[15] Una
frase mai detta è: “Fate e fate presto”.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)