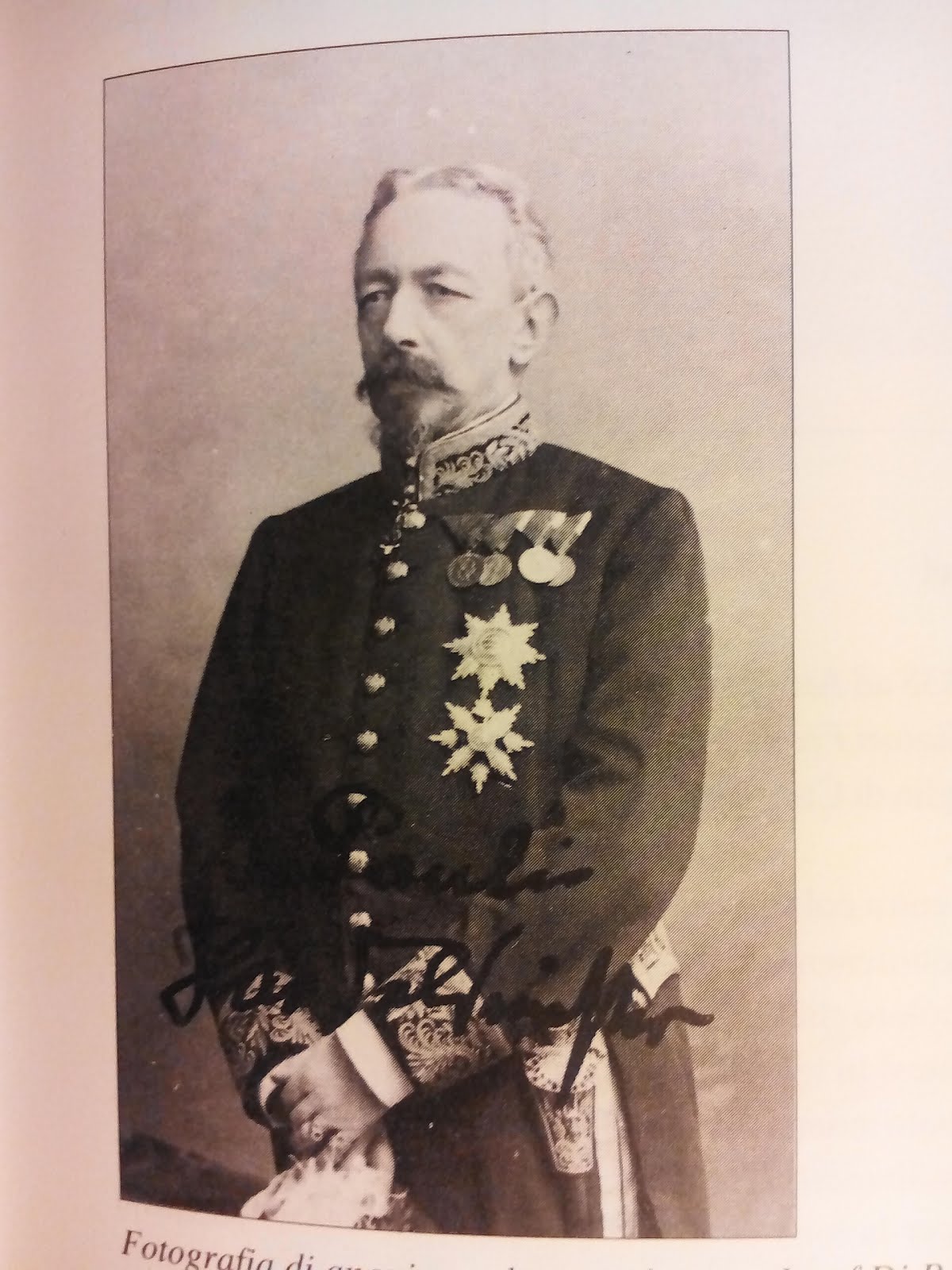INFOCESVAM
BOLLETTINO
NOTIZIE DEL CENTRO STUDI SUL VALORE MILITARE
centrostudicesvam@istitutonastroazzurro.org
____________________________________________________________________
ANNO XII, 71/72/, N. 6, Novembre -
Dicembre 2025, 1 Gennaio 2026
XII/6/1076 La
decodificazione di questi numeri è la seguente: XII anno di edizione, 6 il
Bimestre di edizione di INFOCESVAM, 1076 il numero della comunicazione dal
numero 1 ad oggi. Il presente Bollettino svolge anche la funzione di
informazione “erga omnes” dello stato, sviluppo e realizzazione dei Progetti
dell’Istituto del Nastro Azzurro, in funzione del supporto scientifico alla
offerta formativa dei Master. Inoltre dal gennaio 2023 ha assunto anche la
funzione di aggiornamento delle attività di implementazione dell’Archivio
Digitale Albo d’Oro Nazionale Dei Decorati al Valor Militare Italiani e
Stranieri dal 1793 ad oggi, con la pubblicazione di un ANNESSO. L’ultima
indicazione aggiorna o annulla la precedente riguardante lo stesso argomento
XII/6/1076 – Nel Mese di
ottobre 2025 è stata inviata la richiesta al Ministero della Difesa – Gabinetto
del Ministro la lista dei progetti di previsto sviluppo dal parte del CESVAM –
Istituto del Nastro Azzurro. Nello scorso numero di INFOCESVAM sono stati
indicati dei dodici presentati, i titoli di dieci progetti. In questo numero si
indicano i rimanenti,
XII/6/1077 – www. valoremilitare.blogspot.com.
Nel primo semestre del 2025 si sono avuti oltre 58.000 contatti in
sei mesi, con i mesi di maggio e giugno veramente anomali con oltre 19.000
contatti mensili. Nel II semestre 2025, in sei mesi, 28.000. La media mensile è
di circa 7000 contatti, un dato lusinghiero. Mese di novembre 3177, mese di
dicembre 8815.
XII/6/1078 - Canale You
Tube dedicato all’Istituto del Nastro Azzurro. Schort Video Mese di novembre, 4 Video, mese di dicembre 4 video.
Redazione ed edizione a cura del CESVAM I video (Gli Schort Video) sono
trasmessi ogni lunedì, (ore
08.00). Titolo Canale ISTITUTO NASTRO
AZZURRO CESVAM. Parola chiave CESVAM. Al 31 dicembre 2025 vi erano iscritti 90
persone.
XII/6/1079 –“Progetto
2026/5”. Un Bosco per resistere. “La brigata partigiana “Ciro Menotti” tra le
Provincie di Treviso Pordenone e Belluno. Dott.ssa Monica Apostoli. Progetto
Presentato al Gabinetto del Ministro
XII/6/1080 – Il Master di
1° Liv. in “Storia Militare Contemporanea. Dal 1976 a oggi, ha un totale di
iscritti per l’anno accademico in corso pari a 14 unità; Hanno chiesto
l’assegnazione della tesi il 47% degli iscritti e per la prossima sessione di
laurea di Marzo 2026 sono candidati 2 frequentatori.
XII/6/1081 - Progetto
2026/2. Partecipazione e testimonianze nelle Missioni di Pace Valore Militare e
contributo alla memoria Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle
missioni internazionali per la Pace. Massimo Coltrinari Luigi Marsibilio Paola
Bosio. Continua la raccolta delle testimonianze, che peraltro, dovrebbe essere
incrementata.
XII/6/1082 - www. storiamilitare.blogspot.com.
I contatti nel mese di novembre sono stati 3177, nel
mese di dicembre 3107, per un totale dalla apertura del blog di 144456
contatti.
XII/6/1083 - Volume Serie
Università. Alessia
Biasiolo. “La Fabbrica che costruisce la Storia”. Analisi della produzione
industriale italiana tra Ottocento e Novecento”. Dalla Casa Editrice. Ricevuta
Bozza n. 2 e Bozza 3 per l’inserimento della iconografia.
XII/6/1084 – Progetto
2026/11. “Altius Tendo” Storia del 3° Reggimento Alpini dalle orgini ad oggi.
Dott. Davide Corona. Progetto presentato al Gabinetto del Ministro
XII/6/1085 - Canale You
Tube dedicato all’Istituto del Nastro Azzurro. Long Video Mese di novembre, 4 Video, mese di dicembre 4 video.
Redazione ed edizione a cura del CESVAM I video (I Long Video) sono trasmessi ogni giovedì, (ore 08.00). Titolo Canale ISTITUTO NASTRO AZZURRO CESVAM.
Parola chiave CESVAM. Al 31 dicembre 2025 vi erano iscritti 90 persone.
XII/6/1086 - www.uniformologia.blogspot.com.
I contatti nel mese di novembre sono stati 2353, nel
mese di dicembre 803, per un totale dalla apertura del blog di 134148 contatti.
XII/6/1087 Il Master di
1° Liv. in “Politica Militare Comparata. Dal 1960 ad oggi”ha un totale di
iscritti per l’anno accademico in corso pari a 13 unità; Hanno chiesto
l’assegnazione della tesi il 23% degli iscritti e per la prossima sessione di
laurea di Marzo 2026 sono candidati 3 frequentatori.
XII/6/1088-www.studentiecultori.blogspot.com.
I contatti nel mese di novembre sono stati 495, nel mese
di dicembre 1458, per un totale dalla apertura del blog di 59075 contatti.
XII/6/1089 - Storia del Nastro Azzurro. Labari. Sulla base
dell’Ordinamento del 1981, si è avviata una ricerca delle Sezione Gruppi chiusi
per individuare se ancora esistono o meno le loro insegne, ovvero i Labari e i
Gagliardetti. Al momento le aree di ricerca sono nelle Marche e in Liguria,
XII/6/1082 - www.studentiecultori.blogspot.com.
I contatti nel mese di novembre sono stati 459, nel mese
di dicembre 1384, per un totale dalla apertura del blog di 86145 contatti.
XII/6/1090 - Canale You
Tube dedicato all’Istituto del Nastro Azzurro. Materiali per la Storia del
Nastro Azzurro Schort Video. Dal mese di Gennaio 2026, ogni mese, a cadenza
settimanale, saranno pubblicati 4 Schort Video dedicato ad una fonte o materica
o documentale riferita all’Istituto del Nastro Azzurro. al fine di avere
materiali per una eventuale stesura, come detto, di una storia dell’Istituto.
Uscita ogni sabato, ore 08.00.
XII/6/1091 - Il Master di
1° Liv. in “Terrorismo ed Antiterrorismo” ha
un totale di iscritti per l’anno accademico in corso pari a 116 unità;
Hanno chiesto l’assegnazione della tesi il 22% degli iscritti e per la prossima
sessione di laurea di Marzo 2026 sono candidati 10 frequentatori.
XII/6/1092 -www.studentiecultori.blogspot.com.
I contatti nel mese di novembre sono stati 1740,, nel
mese di dicembre 1472 , per un totale dalla apertura del blog di 49876
contatti.
XII/6/1093 – I progetti
presentati al Ministro della Difesa – Gabinetto del Ministro hanno come autori
i seguenti: Massimo Coltrinari, Giovanni Riccardo Baldelli, Antonio Vittiglio,
Monica Apostoli, Giorgio Madeddu, Osvaldo Biribicchi, Manuel Vignola, Antonio
Daniele, Massimo Dionisi, Davide Corona, Luigi di Santo.
XII/6/1094 -www.atlanteamerica.blogspot.com. I contatti nel mese
di novembre sono stati 1059,, nel mese di dicembre 1957 , per un totale dalla
apertura del blog di 46870 contatti.
XII/6/1095 - La edizione
il CESVAM Report 2021 – 2025. È disponibile. Tale Report è in distribuzione
anche nella versione pdf. Questo è il III Report del CESVA, dopo quello del
2014- 2019 e 2019-2021.
XII/6/1096 - Sito del
Nastro Azzurro: www.istitutodelnastroazzurro.org
riporta fino al 31 dicembre 2025 nel Banner “Il Valore Militare Oggi” gli atti
di Valore che si sono avuto nel passato.
XII/6/1097 – Progetto
2026/10. Gli “Alpini” nella Guerra di Liberazione 1943 -1945. . Dott. Davide
Corona. Progetto presentato al Gabinetto del Ministro
XII/6/1098 _ Blog
Geografici. La visione totale degli accessi di questo gruppo di Blog fa emergere
che i contatti sono in media oltre il
1500/2000 mese, tranne per Italia, che è
di 382, che peraltro è il massimo avuto dalla apertura., e le Terre Polari, che
si attesta sui 880 accessi.
XII/6/1099 -– Progetto
2025/1. Eccidi in Toscana. Cav.Stefano Mangiavacchi sta controllando la lista degli Eccidi da 2 a 9 Vittima. Da 10 a 49 Vittime, nelle 10
provincie toscana; data e luogo
XII/6/1100 - Prossimo
INFOCESVAM (gennaio -febbraio) sarà pubblicato il 1 marzo 2026. I precedenti
numeri di INFOCESVAM (dal gennaio 2020) sono pubblicati su www.cesvam.org e sul
sito dell’Istituto del Nastro Azzurro/ comparto CESVAM. e sui vari blog sia storici
e che geografici.
(a cura di Massimo Coltrinari) info:
centrostudicesvam@istitutonastroazzurro.org